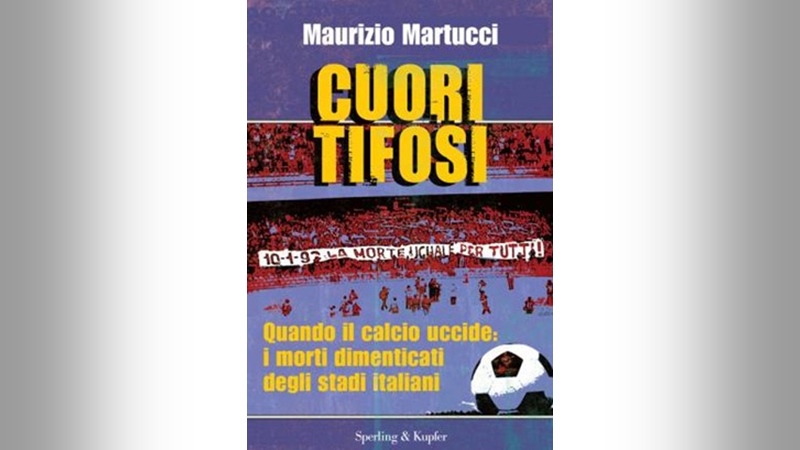L’Italia è un Paese che vive di calcio e troppo spesso, purtroppo, di calcio muore. E che, soprattutto, fatica a ricordare
Non bisogna per forza scomodare l’interessante tradizione della sociologia dello sport – in Italia purtroppo ancora poco radicata – per comprendere l’importanza dei fenomeni sportivi per un consorzio sociale, specie in una società in cui il loisir è un elemento centrale dei legami, delle appartenenze, delle pratiche e delle identità. Di fatto lo sport, nel nostro paese soprattutto il calcio, è un territorio in cui si esprimono gli standard culturali e in cui si riverberano anche intense tensioni sociali più o meno consolidate. E il calcio in Italia, come più o meno ovunque, ha una storia fatta non solo di agonismo e competizione sportiva, non solo di passione culturale e tifo sgargiante, non solo di professionalizzazione crescente ed interessi economici, per altro non sempre solari.
La storia, si sa, ha tante biforcazioni, e gli eventi, i simboli, gli oggetti a volte fanno fatica ad appropriarsi delle narrazioni collettive capaci di lasciare effettivamente traccia durevole e di radicarsi nella coscienza di un gruppo, forgiandone l’identità e orientandone l’azione. Più spesso essi si perdono nel flusso incessante di fatti passeggeri che si succedono senza presa alcuna e intasano i canali della comunicazione più o meno ufficiale, buoni a volte solo per incrementare un effimero sensazionalismo mediatico o per accreditare un discorso pubblico ad uso e consumo di interessi di parte.
È questo sovente il caso della violenza legata al mondo calcistico. Un fenomeno complesso, dagli innumerevoli rivoli e con un corpo di agenti e fattori in gioco molto articolato e mai uniforme. Violenza è quella delle risse tra giocatori; è l’estemporanea intemperanza dei tifosi – che si può esprimere in cori oltraggiosi, lancio di oggetti o petardi, invasioni di campo più o meno deleterie; è lo scontro programmato, nello stadio o al suo esterno, tra gruppi di tifoserie rivali legate da rancori consolidati nel tempo; è l’insieme di atti vandalici che possono avere luogo nei centri cittadini o nell’ambito dei trasporti; è la dinamica di cariche e contro-cariche che contrappongono i fan alle forze dell’ordine; e tanto altro.
In alcuni casi, addirittura, vengono catalogate nell’alveo delle violenze legate al calcio alcune disgrazie o catastrofi – tipo l’effetto micidiale di una calca enorme e magari spaventata che preme sulle recinzioni – che hanno origine piuttosto nell’imperizia o nell’imprudenza delle parti in causa (club, federazioni, autorità), oppure nella vetustà degli impianti, anche se di tutto si tratta tranne che di aggressioni fisiche intenzionali o consapevoli.
Processi insomma variegati, che mettono in gioco aspetti e variabili diverse, fatte di interessi più o meno leciti, appartenenze e inimicizie su cui si fonda la coesione dei gruppi, luoghi vicini e distanti dall’effettivo svolgimento delle competizioni, interazioni complicate nelle concrete situazioni in cui gli eventi hanno luogo (si pensi alla dinamica intricata, piena di articolate strategie, azioni e reazioni reciproche, con cui si fronteggiano polizia e supporter più o meno esagitati), e così via.
Parliamo di fenomeni, tra l’altro, che negli anni hanno interessato molteplici studiosi, soprattutto in Inghilterra, con l’insieme di interpretazioni diverse, e a volte contrastanti, che ne sono scaturite. Come la scuola di Leicester – emanazione diretta della sociologia di Norbert Elias – secondo cui, in brutale sintesi, l’autocontrollo tipico del processo di civilizzazione si scontra con una sorta di zona franca rappresentata dal comportamento della dura working class, quella maggiormente implicata nel teppismo calcistico, orientata secondo i valori di una mascolinità aggressiva (cfr. Elias, Dunning, 1989; Dunning, Williams, Murphy, 1984, 1988, 1990); oppure come l’analisi marxiana di Ian Taylor – forse un po’ troppo partigiana – che interpreta la violenza come reazione all’esclusione sociale e all’imborghesimento del mondo del calcio da parte delle classi più disagiate (Taylor, 1971); o, ancora, come le ipotesi di Peter Marsh e Gary Armstrong – da non considerare coincidenti, per la verità – focalizzate sull’impianto rituale, più che concretamente violento, dei tifosi, il cui comportamento è strutturato sulla partecipazione a rituali che esprimono un temperamento aggressivo giovanile o un’identità operaia maschile (Marsh, 1978; Armstrong, 1998). Ciò solo per esemplificare il variegato quantitativo di sforzi profuso da ricercatori soprattutto britannici, anche se non solo.
Insomma, ci troviamo di fronte ad una realtà davvero contorta. E questa complessità è l’ossatura su cui si regge il libro di Maurizio Martucci, Cuori Tifosi. L’intento dell’autore non è quello di fornire modelli esplicativi della violenza nel calcio, ma quello di ricostruire una memoria cronachistica legata alle vicende di tutti i tifosi che in Italia, dall’inizio del Novecento ai giorni nostri (nel 1920, per la precisione, si ha il primo caso documentato), hanno perso la vita in occasioni in qualche misura connesse allo sport nazionale. Come egli stesso scrive nella sua introduzione: “Certo, di calcio si è morti per l’esasperazione di una lotta fratricida covata negli ambienti più estremi delle curve. Di calcio si è morti per agguati, per il vandalismo scatenato sui vagoni ferroviari, per gli scontri tra le opposte fazioni, per il lancio di razzi e di bombe carta o per le aggressioni premeditate condotte all’arma bianca.
Ma di calcio si è morti anche durante le cariche dei reparti della squadra mobile, dei carabinieri o per le pallottole esplose con troppa superficialità dalle forze dell’ordine. Di calcio si è morti anche per la malasanità, per la lentezza dei soccorsi e per la carenza di adeguate misure di protezione sulle gradinate. Non ultimo, si è cercato di far passare il teorema che di calcio si potesse morire anche quando questo tormentato mondo non c’entrava affatto e lo stadio più vicino si trovava a centinaia di chilometri di distanza dalla scena del delitto e con loro, i tifosi, assenti (una volta tanto) giustificati…” (Martucci, 2010, pp. XI-XII).
Da Augusto Morganti, morto nel maggio del 1920 a Viareggio a causa di un colpo di rivoltella sparato a bruciapelo da un carabiniere, fino ad Eugenio Bortolon, caduto da una balaustra dello stadio Tardini di Parma nella primavera del 2009, passando per vicende e nomi noti (Vincenzo Paparelli, Nazzareno Filippini, l’Heysel, Gabriele Sandri) o anche molto meno celebri, a volte per tanti di noi pressoché sconosciuti. Si tratta di ventisei episodi che coinvolgono tifosi a vario titolo, spesso pacifici e non ultrà turbolenti, la cui triste sorte ha forse riempito notiziari e pagine di giornali nel clamore momentaneo e fugace, ma il cui ricordo non sempre è stato capace di alimentare una solida memoria collettiva, comune all’intero corpus sociale.
L’autore, a tal proposito, ricostruisce il dibattito che ognuna di queste morti ha suscitato. Cerca inoltre di comprendere in che misura un impianto commemorativo – composto di tutte le forme di oggettivazione della memoria come insegne, tornei celebrativi, slogan, striscioni da stadio – è riuscito a preservare un ricordo duraturo, e chi ne è stato portavoce e chi beneficiario. Ne emerge una memoria che difficilmente è stata capace di andare oltre l’ambito del privato o del ristretto mondo dell’appartenenza al gruppo dei tifosi o degli appassionati. Morti che dunque sono diventati simboli di coesione per associazioni o sodalizi di supporter, hanno vivificato i loro rituali e cementato la loro identità. Ma che a fatica hanno travalicato questo mondo per arricchire rappresentazioni e legami più ampi. Traumi, insomma, che non sono stati incorporati nell’alveo delle narrazioni utili a contrassegnare la coscienza di un’intera società civile, a dirigere la sua auto-rappresentazione e, se vogliamo, a forgiare un impegno civico e politico.
In fin dei conti, non siamo qui di fronte a rievocazioni che hanno alimentato più di tanto la “memoria pubblica” (Jedlowski, 2002), ovvero il campo trasmissibile dei discorsi della sfera pubblica, quell’agorà dove hanno luogo vivaci e produttivi confronti di idee, ipotesi, giudizi e proposte su argomenti di interesse collettivo – differenti, oseremmo dire, dal transitorio fragore sensazionalistico del puro fracasso mediale. Forse questi simboli di identificazione non sono rilevanti per le élite che predispongono ciò che va ricordato e quanto invece cade nell’oblio, in virtù di quelle rappresentazioni ufficiali su cui spesso è più facile che poggino appartenenze ampiamente condivise. Tracce che, insomma, difficilmente diventeranno elementi di un passato istituzionalizzato e trasmesso alle generazioni attraverso i canali pubblici. Anche per questo, il libro di Martucci si propone esplicitamente di diventare una roccaforte del ricordo, un piccolo ma significativo tassello della memoria collettiva, ovvero, nella celebre formulazione di Maurice Halbwachs: “… una corrente di pensiero continuo, di una continuità che non ha niente di artificiale, in quanto non ritiene del passato che ciò che è ancora vivo o capace di vivere nella coscienza del gruppo di cui fa parte” (Halbwachs, 1987).
I morti del tifo, dunque: mancanze, assenze, che potrebbero essere ancora vitali nella reminiscenza di tragedie utile a riconoscersi come collettività, utile a sentirsi tale con il collante di emozioni condivise intersoggettivamente, utile a compattare il legame sociale in maniera prolungata. Altrimenti sarebbe come morire più volte, altrimenti sarebbe come perpetuare un trauma costantemente irrisolto.
di Luca Bifulco – www.quadernidaltritempi.eu
Maurizio Martucci
Cuori Tifosi
Sperling & Kupfer