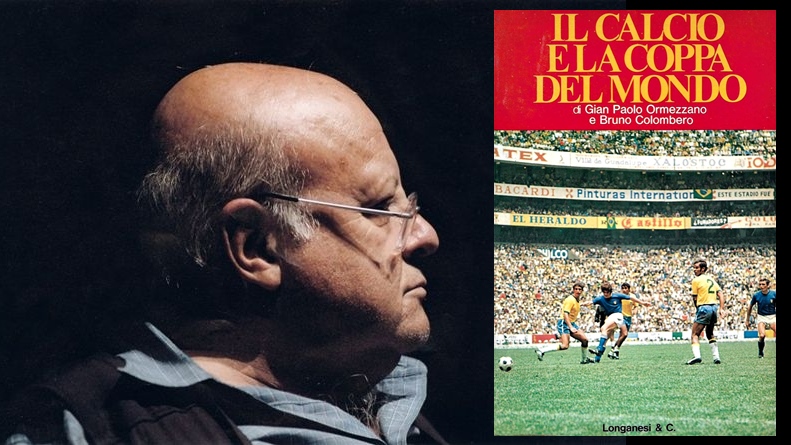In questo libro, pubblicato alla vigilia dei Mondiali del 1978, Ormezzano si tiene, salvo qualche occasione, al di sopra della tecnica preferendo spiegare che cos’è e che cosa rappresenta un campionato del mondo di calcio nella storia dello sport. Ricordare episodi e curiosità serve all’autore per esemplificare, per sottolineare situazioni che si ripetono. Così il discorso sull’inserimento di una manifestazione come il Mundial nella situazione politica, interna ed internazionale, dell’Argentina, prende le mosse dal ricordo di quanto avvenne alla vigilia delle Olimpiadi di Città del Messico, dal massacro degli studenti nella piazza delle Tre Culture. «Lo sport scelse allora di andare avanti nonostante tutto — scrive Ormezzano —. Da quel momento i governi furono legittimati a non tornare mai indietro. Il governo argentino non ha fatto che allinearsi perfettamente a questo vangelo speciale al quale, non vi è dubbio, aderirebbero tutti i regimi del mondo, se sollecitati in presa diretta». Sport, implicazioni politiche, tutto nel libro è trattato con franchezza e senza falsi moralismi.
L’edizione 1982 del campionato mondiale di calcio avrà luogo in Spagna. Si calcola che la partita di finalissima avrà più di due miliardi di telespettatori. In pratica, al mondo, una persona su due assisterà alla saga dei ventidue uomini che corrono dietro a un pallone, nonché allo straordinario fatto disciplinare degli stessi ventidue, ognuno stella, anzi cometa con uno strascico colossale di interessi, sottomessi alla disciplina, agli ordini di una sola persona, l’arbitro.
Facile prevedere che nel 1982 il calcio mondiale trarrà la sua forza e dal suo colossale anacronismo e dalla sua favolosa attualità. Il fenomeno, che già adesso si staglia nel panorama sportivo, e non solo sportivo, del mondo per la sua mole impressionante, sarà ancora più macroscopico. Soltanto i grandi eventi terrificanti potranno, sul piano emozionale, concorrenziare nel mondo la finalissima della massima coppa calcistica. Soltanto un grande evento, quasi necessariamente tragico, potrà provocare le stesse scariche di andrenalina di un gol. E in ogni caso non con l’immediatezza della teletrasmissione certa, preannunciata dal vivo.
Nel 1977 il calcio, da intendere ormai come fenomeno sociale di cui la parte strettamente sportiva è soltanto una componente, benché a un certo punto risulti l’assoluto terminale, il calcio, dicevamo, si è aggiudicato circa un miliardo e mezzo di tifosi. Una tournée in Asia della squadra statunitense dei Cosmos, newyorkesi, capitanata dal negro brasiliano Pelé, ha portato il calcio rutilante in Cina e in India. Scene di fanatismo in entrambe le nazioni, con eco dell’evento, peraltro tecnicamente insignificante, nel mondo intero.
Ora, si consideri bene tale evento. I motori di esso, cioè da un lato i protagonisti del rito calcistico dentro il campo, dall’altro le folle, erano, sono rappresentativi di quattro regimi politici profondamente diversi, per non dire situati addirittura ai quattro punti cardinali: quello statunitense, quello brasiliano, quello cinese, quello indiano. Eppure il calcio è stato una sorta di Internazionale, è stato il comune denominatore, minimo o massimo non importa, per tutti questi uomini dipendenti da diverse situazioni politiche.
Non risulta che i sociologi, di solito attentissimi a penetrare anche le pieghe, anche le molecole del fenomeno calcistico, quando li disturba nella loro quiete domenicale, abbiano ravvisato l’importante momento cosmico, che in un certo senso anticipa e legittima le nostre previsioni riguardanti la presenza di oltre mezzo mondo davanti al video nel 1982. Previsioni che peraltro divengono già realtà per quella che è l’undicesima edizione della Coppa calcistica del Mondo, in programma in Argentina dal 1 al 25 giugno 1978. Telespettatori calcolati, per la finalissima, dal rni bardo in su. Certezza assoluta nel più grande spettacolo del mondo e nel più grande teatro del mondo. Prodromi di assoluta importanza: il 14 gennaio dello stesso 1978, anno davvero di grazia per non dire anno del Signore (ma chi è il Signore, il football?) seicento giornalisti provenienti da tutti i paesi del mondo oltre che, naturalmente, dall’Argentina, si sono assiepati in un ’salone del centro di Buenos Aires per assistere a una cerimonia di per se stessa meccanica e insignificante: il sorteggio, abbondantemente pilotato dalle decisioni prese due giorni prima, dei quattro gironi per la prima fase finale della Coppa del Mondo.
Un bambino di tre anni, il brasiliano Ricardo Teixeira Havelange, nipote del presidente del massimo organismo calcistico mondiale, la FIFA, cioè la Fédération Internationale de Football Association, ha calato la propria mano, decisamente vergine, nell’urna per estrarre dei cilindri, all’interno dei quali era contenuto il biglietto con il nome della squadra designata a far parte di questo o di quel raggruppamento.
Nel 1962, a Santiago del Cile, in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo che doveva disputarsi in quell’anno nella nazione andina, i giornalisti non cileni erano soltanto due, provenienti dalla vicina Argentina: uno argentino, l’altro italiano.
Il fenomeno della Coppa del Mondo prossima ventura e di tutto il calcio che ci aspetta dietro l’angolo, è essenzialmente un fenomeno televisivo. Sono stati fatti i conti in tasca al pugile statunitense negro Cassius Clay, al tramonto della sua carriera: i trentasei miliardi di lire che ha guadagnato sono stati in larga parte acquisiti negli ultimi anni, quando la televisione è diventata mondovisione, quando i satelliti sparati lassù, in alto nel cielo, hanno permesso la facile visione a tutti nel mondo degli incontri disputati magari in una località assolutamente sconosciuta prima.
La stessa televisione che si è impadronita, subito sezionandoli, laparatomizzandoli, dei Giochi Olimpici, si appresta a effettuare, nei riguardi del calcio, un’operazione di dare-avere colossale, probabilmente senza nessun altro riscontro economico di pari portata in tutto il mondo. È assolutamente impossibile fare un calcolo della massa di denaro che una Coppa del Mondo di calcio, diffusa oggi come oggi in tutto il mondo, trascina con sé. È assolutamente impossibile individuare, bipede per bipede, la spesa che l’umanità fa e sostiene, peraltro in perfetta letizia, nel nome del dio pallone.
Non resta, davvero, che riconoscere il fenomeno e accettarlo. Non resta che adattarsi a esso, come si cerca di galleggiare quando si è travolti da un fiume in piena. Tentando, disperatamente, di sfruttare almeno la spinta per andare da qualche parte, tentando di assumere una direzione qualsiasi, ideologica o fisica che sia.
Il problema della dilatazione, dell’elefantiasi ormai delle massime organizzazioni sportive, oltre a essere problema tecnologicamente serio, tremendo per tutti i mass-media che, dopo aver creato il mostro, adesso temono di essere da esso divorati, si raggrinza nel problema umanistico squisito di ogni uomo. Come fare? Cosa fare? Accettare il fenomeno nella sua pienezza, lasciarsi abbracciare da esso? Giocare all’istrice, opporsi? Si va verso un mondo in cui chi riesce a sottrarsi alle seduzioni, alle infiltrazioni televisive in occasione dei grandi eventi sportivi, o è un misantropo assoluto, pressoché pazzo, o è un sublime filosofo.
La Coppa del Mondo di calcio, in un certo senso, esaspera la tematica dei rapporti fra la televisione e l’uomo comune. Essa ormai esiste perché c’è la televisione, così come, sino a quando le telecamere non smisero di funzionare, esistette la Luna, esistettero le imprese lunari.
Jorge Luis Borges, per combinazione proprio argentino, grande fra i grandi scrittori sudamericani, ha ipotizzato la vicenda a Buenos Aires di uno stadio fatiscente, passando accanto al quale lui, il protagonista del racconto, riscontra in se stesso strani allarmismi. Possibile che lo stadio sia ridotto così? Finalmente la risposta viene da un ufficio televisivo: lo stadio è lì soltanto come reperto archeologico, da anni e anni non vi si giocano più partite, gli incontri che la gente vede alla televisione sono ricostruiti in studio, i calciatori sono attori, o se si vuole gli attori sono calciatori. Vengono eseguite azioni preordinate, secondo schemi fissi come quelli di un balletto. Da anni le cose vanno avanti così, i campionati, incontro dopo incontro, sono gestiti dall’ente televisivo, i risultati sono decisi prima e realizzati poi, davanti alle telecamere, secondo copione.
Siamo di fronte all’accettazione del fenomeno televisivo come fenomeno primario per l’esistenza del cosiddetto «spettacolo». La Coppa del Mondo in Argentina, anno 1978, si svolge davanti a folle autentiche, ancora testimoniali, testimonianti. Ma è perfettamente ipotizzabile, fra poco, una Coppa del Mondo gestita tutta dalle telecamere, servita a tutto il mondo con l’attenzione dovuta per certi ingredienti che la rendano gradevole dappertutto.
La Coppa del Mondo 1982 sarà aperta a ventiquattro squadre: quella detentrice del titolo, quella organizzatrice, cioè la Spagna, dodici squadre europee, tre squadre sudamericane, due squadre centroamericane, due squadre africane, due squadre asiatiche, una squadra oceanica. Alla faccia dell’equilibrio tecnico, si cercherà di raggiungere un relativo equilibrio geografico. Si cercherà di far accedere, alla fase finale, le maggiori porzioni di mondo possibile.
La Coppa del Mondo 1978, ancora limitata a sedici squadre nella fase finale, in fondo chiede, pretende di rappresentare il mondo, e ci riesce per un certo sforzo mentale dei terricoli Ma l’Africa ha soltanto una nazione, l’Asia e l’Oceania insieme hanno potuto delegare soltanto l’Iran, il Sudamerica ha tre squadre solo perché l’Argentina è ammessa di diritto come nazione organizzatrice.
È molto difficile sostenere che le sedici squadre impegnate in Argentina per la fase finale rappresentano, geograficamente e socialmente e anche sportivamente, il mondo intero. Per adesso, si affida a queste squadre una sorta di vasta ambasciata, a nome di tutte le altre, nel nome del football.
Ma la Coppa del Mondo sta diventando una cosa tanto immane che nessuna vuole patire l’«onta» di starne fuori. Presto, se non si raggiungerà una rappresentatività sufficientemente diffusa, ancorché tecnicamente assurda, si dovrà arrivare al principio dell’Olimpiade: almeno una presenza per nazione, affinché l’elefantiasi abbia se non altro la caratteristica di essere popolare, democratica.
Sedici squadre prendono dunque parte alla fase finale della Coppa del Mondo, o Coppa FIFA, in programma in Argentina dal 1 al 25 giugno 1978. Sono squadre abbastanza eterogenee, ancorché non tutte ancorate a una realtà calcistica indiscutibilmente valida. L’Europa è presente con dieci squadre: seguendo l’allineamento gruppo per gruppo, sono Ungheria, Francia, Italia, Polonia, Germania Ovest, Austria, Spagna, Svezia, Olanda e Scozia. Grosso modo si può dire che queste presenze rispetto la superiorità calcistica del Vecchio Continente. Però i protagonisti di questa operazione sono arrivati alla fase finale in virtù di prodezze spicciole, più che di magnanimità di lombi. Sono fuori da questa fase finale l’Inghilterra, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, il Portogallo, tutte nazioni che al football hanno dato molto e alle quali il football deve molto. Ci sono dentro, peraltro, poche forze emergenti: casomai la nuova Francia…
Il che vale a dire che anche l’Europa, peraltro favorita nella composizione del girone finale, con tutti i posti a lei concessi, non riesce a esprimere tutto il proprio calcio, patisce e gode le situazioni contingenti, e insomma, pur avendo più spazio in cui muoversi, non è, dal punto di vista rappresentativo, coerente con i suoi valori.
Che dire allora delle altre «regioni» del calcio mondiale? Il Sudamerica presenta l’Argentina nazione organizzatrice, il Brasile e il Perù vincitori di un complesso girone di qualificazione. Passi per il Brasile, magnanimo di lombi, carico come nessun’altra nazione di passato ancora fresco, ancora glorioso. Ma il Perù, terza forza del Sudamerica, è un’esaltazione del calcio improvvisato, è un insulto al calcio aristocratico. Sta fuori, del Sudamerica, l’Uruguay due volte campione del mondo, e ancora ieri l’altro in grado di dare lezioni di calcio giocato, forse fin troppo giocato, a tutto il resto del mondo.
Il Nordamerica, il Centramerica e i Caraibi hanno eletto il Messico, seguendo la falsariga di un pronostico abbastanza facile. Il gruppo asiatico-oceanico ha sprigionato, è il caso di dirlo, l’Iran, alla fine di un complesso girone di qualificazioni in cui è stata eliminata, proprio dagli iraniani, la favoritissima Australia. Infine l’Africa ha proclamato sua rappresentante la Tunisia, per niente considerata nella lunghissima vigilia, e autrice di eliminazioni sensazionali ai danni della Nigeria prima, dell’Egitto poi.
Non esiste assolutamente la possibilità di rintracciare una costante, un’unità, un’ideologia geografica, anzi geopolitica, nelle sedici squadre che disputano la fase finale della Coppa del Mondo. Tutto il vasto movimento sportivo dell’Est europeo è rappresentato soltanto da Polonia e Ungheria. L’Europa Ovest patisce (o gode?) una latinizzazione, attraverso la presenza di Italia, Spagna, Francia e, se si vuole trovare i più latini fra i mitteleuropei, Austria. Svezia e Scozia sembrano presenze abbastanza avventurose. La Germania Ovest è in finale di diritto, come detentrice del titolo. Completiamo la rapida occhiata geopolitica alle sedici elette per la fase finale del calcio mondiale, dicendo che Argentina, Brasile e Perù sono nazioni rette da governi ufficialmente militari. Sulla «militarità» di altri governi, come quello dell’Ungheria, della Polonia, della Tunisia, dell’Iran, dello stesso Messico, si può discutere: ma è fuori dubbio che questa «militarità» è una componente, se non addirittura una costante, di quei governi. Infine, ci sono squadre rappresentanti di paesi cosiddetti «pienamente democratici», fra i quali si è ultimamente inserita, sia pure con qualche fatica, la Spagna. Quattro nazioni sono monarchiche: la stessa Spagna, la Svezia, l’Olanda e la Scozia. Un po’ troppe, per quello che è il panorama complessivo dei governi del mondo.
In sostanza, coloro che ascrivono al calcio, tra le sue forze speciali, quella di essere uno sport avventuroso, ribelle alle normali classificazioni fatte dal mondo, lotteristico quel che basta, possono trovare grossi motivi di conforto alla loro tesi proprio dalla consultazione dell’elenco delle sedici squadre ammesse alla fase finale della Coppa del Mondo. La rappresentatività è relativa, l’accozzaglia è anomala, talune squadre, compresa l’Italia, sembrano «arrivate lì» sullo slancio di risultati contingenti favorevoli, piuttosto che grazie a un viaggio compiuto con tutti i crismi della tradizione, cioè del passato vivo e del presente attivo. Che la palla sia rotonda, nel calcio, non risulta purtroppo soltanto nei novanta minuti della partita. La palla è sempre rotonda, l’imprevedibile è pane quotidiano.
Diventa molto difficile, per non dire impossibile, dare perciò una linea geopolitica nei quattro gironi per la fase finale della Coppa del Mondo. Sembra davvero il gioco di un ragazzino, sembra davvero che le sedici squadre, fatte poche eccezioni, siano scaturite da un altro gigantesco sorteggio, non pubblicizzato dalla televisione, non affidato, nella sua parte conclusiva, a un bambino di tre anni, ma pur sempre sorteggio, pur sempre caso, pur sempre casualità.
Eppure, per una Coppa del Mondo la cui geografia conclusiva non si sposa assolutamente alla geografia calcistica mondiale, e men che mai alla geografia mondiale tout-court, si scomodano interessi vastissimi, si muovono tante economie, a cominciare, è ovvio, da quella argentina, impegnata in una spesa di oltre 700 miliardi, importantissima per un paese economicamente stressato, politicamente disastrato.
Ma qui vale la pena di dire, anche ai fini di una migliore comprensione, in una specie di visione «dietro lo schermo» delle trasmissioni televisive del giugno 1978, cosa ha significato e cosa deve significare la Coppa del Mondo per l’Argentina. Mai il football in passato fu delegato a rappresentare tante istanze, a risolvere tanti problemi. Mai, nella storia di tutte le manifestazioni, sportive e non sportive, una nazione affidò così tanto di se stessa a un evento, o a una serie di eventi collegati fra loro: una sorta di gigantesca scommessa, contro nessuno se non contro se stessa, contro niente se non contro i propri misteri. L’Argentina squassata dalla guerra civile, stremata economicamente dalla crisi del peso, l’Argentina ridotta per molte cose a colonia degli Stati Uniti, l’Argentina nutrita, sorretta, diremmo quasi inamidata dal nazionalismo feroce e assurdo, l’Argentina del problema quotidiano, offre, anzi impone all’undicesima Coppa del Mondo di calcio di riscattarla, attraverso l’unica realtà che ormai conti al mondo, quella televisiva, agli occhi di tutti.
Il governo argentino ha posposto all’organizzazione del campionato del mondo la soluzione di ogni altro suo problema, convinto forse che una buona organizzazione fosse, automaticamente, la soluzione di ogni problema. Ha voluto a tutti i costi, davvero ferocemente (magari legittimando repressioni ancora più dure di quelle abituali, proprio per la necessità di «ripulirsi» di fronte al mondo calcistico, che chiedeva calma per confermare l’assegnazione dell’organizzazione), ha voluto a tutti i costi, dicevamo, andare avanti nei «lavori», rassicurare il mondo intero.
A un certo punto il mondo intero dello sport, anzi del calcio, è stato come «costretto» a dare al governo militare argentino la propria complicità per l’organizzazione della Coppa del Mondo 1978.
Cosa significa «dare la propria complicità» ? Significa accettare che, nel nome della cosiddetta tranquillità sportiva, della cosiddetta pace sportiva, venissero commesse anche atrocità, venissero ulteriormente violati i diritti dell’uomo, tutto per garantire alla vicenda di giugno, al viavai delle sedici squadre su e giù per l’Argentina, onde adempiere al rito complessivo delle trentotto partite, il teatro, il teatrino giusto.
Ancora una volta il mondo dello sport non si è chiesto, tolte rare eccezioni, il perché di una condiscendenza generale, automatica, verso le cosiddette emergenze, per sanguinose che esse siano, di chi deve a ogni costo, a ogni prezzo condurre in porto l’organizzazione dell’evento sportivo stesso.
La prova generale, non solo per l’Argentina 1978, ma per tutte le manifestazioni che verranno, fu fatta nel 1968 a Città del Messico, in piazza delle Tre Culture, quartiere Tlatelolco, quando, nel nome della pace olimpica da garantire a tutti i costi, da difendere da ogni minaccia prima ancora che l’Olimpiade fosse aperta, vennero massacrati dall’esercito messicano centinaia di studenti.
Lo sport scelse allora di andare avanti nonostante tutto. Da quel momento i governi furono legittimati a non tornare mai indietro. Il governo argentino non ha fatto che allinearsi perfettamente a questo vangelo speciale, al quale, non vi è dubbio, aderirebbero tutti i regimi del mondo, se sollecitati in presa diretta. Casomai si può dire che il sacrificio per chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie, nei riguardi della Coppa del Mondo di calcio 1978 è più grosso, più speciale che mai. Davvero pochi altri posti al mondo pretendono tanta sordità, da parte dell’osservatore straniero, relativamente a quello che avviene nella cruda, feroce realtà di ogni giorno, di ogni notte.
Al tempo stesso è fuori di dubbio che comportamenti duri sarebbero messi in atto, ormai, da qualunque governo il quale dovesse far fronte alle colossali esigenze del fenomeno calcistico, e vedesse legata a una buona riuscita della manifestazione stessa larga parte della propria dignità, del proprio prestigio. Ormai i termini della questione sono uguali per tutto il mondo, quale che sia il regime in vigore.
È perfettamente certo che, nei riguardi della sicurezza da garantire a ogni costo a una manifestazione sportiva, una Cina si comporterebbe esattamente come un Sudafrica. Qualcuno potrà dire che in Cina non ci sarà mai bisogno di arrivare a certi estremi, mentre in Sudafrica la tensione sociale è la legge, perlomeno la regola. Ma questo nulla toglie all’altro tipo di certezza, quello che, se per caso o non per caso, una corrente anche di semplice pensiero ostacolasse in Cina l’organizzazione di una grande manifestazione sportiva, lo stato si sentirebbe in diritto-dovere di tutelare il buon andamento, la buona riuscita della manifestazione stessa.
Si deve dire che lo sport ha ormai imposto, ai governanti di tutte le nazioni, questo principio di condotta, specialmente dopo che nel 1972 i feddain, aggredendo la squadra israeliana al villaggio olimpico di Monaco, hanno spaccato la campana di vetro sotto la quale i soloni dello sport credevano di poter continuare indefìnitivamente a respirare la loro aria speciale.
Chissà se questa imposizione pratica ai governi di proteggere lo sport a ogni costo è una conquista o una sconfitta, per lo sport stesso. La Coppa del Mondo di calcio 1978 si farà, in Argentina, sotto la protezione, assolutamente non discreta, dei mitra spianati.
Nel 1974, in Germania Ovest, venne messo a punto un colossale sistema di sicurezza, che funzionò perfettamente, invisibile dovunque, fuorché a Berlino, dove era acquartierato il Cile che giocava contro la Germania Est, a pochi passi dal muro.
Per il resto, la Coppa del Mondo 1974 fu il trionfo dei servizi segreti, così come lo fu, in larga parte, anche l’Olimpiade 1976, organizzata a Montreal nel Quebec francofono, ancora terrorizzato dai terroristi che sei anni prima vi avevano seminato la morte.
C’è chi addirittura vede nello sport l’occasione per grandi allenamenti dei vari poteri alla repressione. Colossali macchine di controllo sarebbero, insomma, messe a punto grazie agli avvenimenti sportivi. Una previsione logica dice che soltanto stati totalitari, o stati democratici che provvisoriamente abdichino a se stessi, potranno nel futuro organizzare Un’Olimpiade, un campionato del mondo.
Disperatamente quelli dello sport cercano di trovare anche in ciò qualcosa di positivo, l’aggancio completo dello sport alla vita. I nostalgici sospirano, i protagonisti dello spettacolo si fanno sempre più impauriti, attenti. Johann Cruyff, olandese, reputato il più grande calciatore del mondo, ha rinunciato a prendere parte, con la Nazionale del suo paese, alla fase finale della Coppa mondiale in Argentina, per una ragione pura e semplice che si.chiama paura. Una qualsiasi azione dei guerriglieri (o dei terroristi, come li chiama il governo argentino) avrebbe probabilmente riguardato la sua persona: lui, Cruyff, sarebbe stato senz’altro il bersaglio piu interessante, il primo uomo da cercare, da rapire. Qualcuno dice che ha avuto il coraggio di aver paura, qualcuno dice che neppure questo coraggio ha avuto se si è mascherato dietro grossi impegni per la sua nuova vita di uomo d’affari, dietro il suo ritiro, comunque, dal football.
Ma resta il fatto che una grande strada è stata percorsa, chissà se in avanti o indietro, da quando, anno 1930, prima edizione della Coppa calcistica del Mondo, l’arbitro della partita di finale, fra Uruguay e Argentina, il belga Langenus, trentanovenne, pretese di essere assicurato sulla vita. Era, la sua, una pretesa eccessiva, per quei tempi. Giocavano gli uruguaiani, padroni di casa, contro gli argentini, ventimila tifosi di Buenos Aires avevano attraversato il Rio della Piata, erano accaldati, pieni di speranza, ma allegri, sereni. L’arbitro comunque riuscì a ottenere addirittura la presenza, nel porto di Montevideo, di un battello equipaggiato per una fuga veloce.
L’Argentina era in vantaggio, al termine del primo tempo conduceva per 2-1, alla fine fu sconfitta per 4-2. L’arbitro fu portato in trionfo, come tutti i giocatori uruguaiani. Le sue paure, condivise dai governanti dell’epoca, appaiono adesso ridicole, patetiche, se si vuole simpatiche, con un buon profumo di cosa antica.
Adesso le autoblindo all’interno degli stadi sono la prassi, gli arbitri vengono scortati anche in albergo da gorilla più o meno discreti. È cambiato il mondo intorno allo sport, intanto che lo sport si è fatto sempre più vita: e il calcio, sport vitale, della vita ha tutto, gode tutto, ma anche spartisce tutto. Se si vuole, questa è una nuova disperata forma di dignità.
Siamo arrivati, implicitamente, alla storia della Coppa del Mondo. Abbiamo detto più volte di undicesima edizione. Effettivamente l’Argentina aspetta di proclamare per l’undicesima volta da che la sfera di cuoio rotola, secondo regolamenti immutati da ormai un secolo, sui campi di tutto il mondo, la squadra migliore di tutte, o migliore nella manifestazione deputata a stabilire una graduatoria.
Il campionato mondiale di calcio è nato ufficialmente il 18 maggio 1929. L’occasione fu il diciottesimo congresso della FIFA, tenuto a Barcellona. Il francese Jules Rimet, presidente dell’organismo mondiale, ex calciatore, si allacciò al successo del calcio nei Giochi Olimpici di Amsterdam 1928, per chiedere l’organizzazione di una manifestazione che avesse un profondo respiro ecumenico e che al tempo stesso permettesse al football mondiale di presentare tutti i suoi migliori talenti, non soltanto quelli in regola con le leggi olimpiche.
Bisogna tener presente che allora il dilettantismo olimpico era, almeno formalmente, imposto a tutti i livelli. Raimundo Orsi, argentino di origini italiane, migliore giocatore delle Olimpiadi di Amsterdam, dove la sua squadra aveva ceduto soltanto in finale all’Uruguay, subito dopo i Giochi si era trasferito alla Juventus di Torino, per un ingaggio a quell’epoca stratosferico: 100.000 lire e una vettura Fiat 509, oltre a uno stipendio di 8.000 lire mensili, superiore a quello di qualsiasi altro funzionario del regno d’Italia. Per un anno non aveva avuto la licenza, ma aveva preso lo stipendio ugualmente.
Il calcio, guidato a livello mondiale dal francese Rimet, comprese che non poteva non darsi una propria manifestazione mondiale, a meno di accettare che il torneo olimpico diventasse il faro principale dell’attività calcistica di tutto il globo; e al tempo stesso decise che questa manifestazione fosse davvero aperta a tutti 1 talenti, godesse di leggi speciali, riguardasse indifferentemente i giocatori professionisti e quelli dilettanti. Jules Rimet parlò subito di una manifestazione da sfalsare di due anni rispetto ai Giochi Olimpici, i quali avrebbero continuato a organizzare il loro torneo calcistico limitato agli assoluti dilettanti. Una coppa raffigurante la Vittoria alata, alta trenta centimetri, pesante quattro chilogrammi, dei quali poco meno di due di oro fino, del valore di cinquanta milioni di franchi, opera dell’orafo parigino Abel Lafleur, fu presentata da Rimet e offerta a quella federazione che avesse per tre volte, anche non consecutive, vinto il titolo mondiale. La proposta di Rimet venne accolta, la coppa fu intitolata al suo nome, nacque il campionato del mondo. Ci pare interessante, sul piano della curiosità peraltro legittimata dalla sua aderenza ai grandi temi politici delle varie epoche, seguire anche le vicissitudini fisiche, materiali di questa coppa.
Quando venne detenuto dall’Italia, campione del mondo nel 1934, nel 1938 e, mentre la manifestazione non veniva organizzata, per tutti gli anni della seconda guerra mondiale, il trofeo, custodito presso la Federazione italiana, fu salvato dalle razzie dei nazisti da Ottorino Barassi, presidente della Federcalcio, che la nascose sotto il suo letto, avvolto in fogli di giornali.
Tornata la tranquillità per il mondo, e anche per i detentori o tenutari che dir si voglia della coppa, il trofeo intitolato a Jules Rimet, morto nel 1956, conobbe le «emozioni» del furto quando, esposto nelle sale di una mostra filatelica, alla Central Hall di Westminster a Londra, venne rubato il 20 marzo 1966. In quell’estate l’Inghilterra doveva organizzare la competizione mondiale, (i fu panico per la sparizione della coppa, ritrovata poi in un giardino alla periferia di Londra, grazie al fiuto di un cagnolino subito celebre, di nome Pickles, e grazie forse a una «soffiata» di un informatore della polizia.
Vincendola per la terza volta, il Brasile si aggiudicò nel 1970 la Coppa Rimet. Pelé, 1 unico giocatore al- mondo capace di vincere per tre volte il titolo mondiale, tenne alto il trofeo che poi passò negli archivi della Federcalcio brasiliana. Diventò indispensabile stanziare il denaro per un nuovo trofeo, fu lanciato un concorso; il progetto di un italiano, Silvio Gazzaniga, di Milano, trionfò su cinquantadue altri. La coppa ora intitolata alla FIFA, pesante cinque chilogrammi in oro massiccio, alta trentasei centimetri, valore oltre venti milioni, raffigurante due atleti stilizzati sormontati dal globo terrestre, è in palio. Non è però prevista nessuna assegnazione definitiva a nessuna federazione. Semplicemente, chi vince un’edizione è autorizzato a far incidere il suo nome sul piedistallo. Per adesso c’è il nome della Germania Ovest, vittoriosa nell’edizione 1974.
La coppa è stata sistemata in una banca di Buenos Aires, e il 14 gennaio è stata tirata fuori per la cerimonia televisiva del sorteggio del campionato mondiale 1978.
Il 25 giugno, alle 20 italiane, scenderanno in campo le squadre che dovranno, nella finalissima, aggiudicarsi il trofeo, almeno in senso morale (si tenga conto comunque che una copia del trofeo stesso verrà consegnata definitivamente alla squadra vincitrice). Alle 21.45, ora italiana, si saprà il nome della squadra che, dopo la Germania, avrà il diritto di far incidere il suo nome sul piedistallo della Coppa FIFA.
La lunga storia di questa coppa, di questa manifestazione, ebbe inizio nel 1930.
Il calcio italiano godeva in quegli anni di ottima salute. Il campionato 1929-30 aveva visto l’avvento del girone unico, senza più la spaccatura dell’Italia calcistica in due gironi. Aveva vinto l’Ambrosiana Inter con 50 punti, davanti al Genoa con 48 punti e alla Juventus con 45 punti. Le squadre erano diciotto.
Nell’Ambrosiana Inter giocava Meazza, il più grande calciatore di allora, forse il più grande calciatore italiano di ogni tempo.
La squadra che meglio poteva lottare con l’Ambrosiana, il Genoa, aveva perduto per un infortunio, in un incontro amichevole, il centravanti Guillermo Stabile, proveniente dall’Argentina, soprannominato «el filtrador» per la sua abilità nel perforare le difese avversarie. Con la gamba rotta, Stabile aveva chiuso troppo rapidamente la sua carriera.
La Juventus, terza, stava mettendo a punto la squadra che avrebbe poi trionfato per un quinquennio. Aveva chiamato dall’Argentina, dopo Orsi, anche Monti, Cesarini e il brasiliano Sernagiotto.
L’Italia era in ottima salute calcistica, ma ragioni economiche, o forse soltanto motivi di prudenza finanziaria, consigliarono alla Federazione di non prendere parte alla prima edizione della Coppa Rimet, organizzata dall’Uruguay, che aveva dato enormi garanzie, compresa quella, più importante di tutte, dell’ospitalità gratuita alle compagini partecipanti. Montevideo aveva inaugurato per l’occasione il suo stadio da centomila posti, chiamato Stadio del Centenario. Solo tredici nazioni avevano accettato l’invito: quattro europee (Jugoslavia, Romania, Belgio e Francia), tutte le altre americane (Messico, Argentina, Cile, Brasile, Bolivia, Uruguay Perù, Stati Uniti e Paraguay). ’
Le partite cominciarono il 13 luglio, il torneo si concluse il 22 Argentina, Stati Uniti, Uruguay e Jugoslavia passarono nelle semifinali; la qualificazione più sorprendente fu quella della Jugoslavia che eliminò il Brasile con un 2-1 e la Bolivia con un 4-0.
Anche gli statunitensi, rinforzati da elementi scozzesi, si fecero ammirare, eliminando Paraguay e Belgio, sempre battuti per 3-0.
In semifinale, però, il calcio vero e proprio ripristinò i suoi valori: l’Argentina e l’Uruguay superarono rispettivamente gli Stati Uniti e la Jugoslavia, sempre con il punteggio di 6-1.
Si arrivò alla previstissima finale fra Uruguay e Argentina. Era la ufficializzazione del calcio artistico, della finta, del dribbling stretto. Novantamila persone, il 30 luglio, si presentarono allo stadio per assistere alla partita. Si temevano grossi incidenti, ma l’Uruguay vinse abbastanza nettamente (4-2), dopo aver rimontato il vantaggio (2-1) dell’Argentina.
Tutto sommato, fu un’edizione abbastanza regolare. Nel mondo tuttavia l’eco fu molto relativa. L’Europa aveva snobbato gli inviti, la prima edizione del campionato del mondo sembrò più che altro un grazioso omaggio al calcio sudamericano, che aveva fatto in fretta a recepire dall’Europa i grandi comandamenti di questo sport e a pigmentali col proprio estro.
Nel 1932 il campionato mondiale venne assegnato all’Italia. Il peroratore ufficiale della causa italiana fu l’avvocato Mauro, che nel congresso di Stoccolma riuscì a ottenere il sì da parte della FIFA.
La Federazione italiana presentò un impegno del proprio governo (il regime fascista, cioè) di sostenere eventuali oneri della manifestazione, azzerando eventuali bilanci passivi. Il regime di Benito Mussolini aveva intuito perfettamente le vaste possibilità propagandistiche legate al calcio.
La squadra venne affidata a Vittorio Pozzo, il quale si basò molto sulla Juventus, che in quel 1934 stava rifinendo quella sua colossale serie di scudetti consecutivi (cinque) che le avrebbe dato magnanimità di lombi e prestigio sicuro per un lungo avvenire.
L’Italia si presentava alle scene calcistiche mondiali con un discreto ruolino di marcia. La sua Nazionale aveva disputato molti incontri, vincendone La più parte. Il conteggio fatto al 31 dicembre 1933, alla vigilia immediata cioè del grande impegno mondiale, avrebbe parlato di 49 vittorie, 28 pareggi e 30 sconfitte su 107 incontri. L’Italia inoltre si era affermata in competizioni internazionali, sia pure ufficiose. Nel 1934 tuttavia la Nazionale azzurra (nel 1911, in omaggio al colore di casa Savoia, le maglie lane e, originali della nostra nazionale, avevano preso il colore in vigore tuttora) aveva perduto a Torino per 4-2 contro l’Austria, e questo nonostante la presenza degli argentini e degli uruguaiani, ormai fatti italiani, nelle nostre file.
Il commissario tecnico Vittorio Pozzo, un piemontese battezzato con l’acqua del Piave, un romantico-nostalgico di bella tempra, ancorché di concetti tecnici non sempre attualizzati, aveva comunque parlato immediatamente di riscossa. E in effetti riscossa fu. Rimandiamo il lettore alla consultazione dell’amplissima parte statistica di questo libro, per ricostruire la «marcia» degli azzurri.
Noi ricordiamo soltanto alcune cose importanti di quell’epoca. Per esempio i titoli dei due principali quotidiani italiani, l’indomani della vittoria in finale, ottenuta faticosissimamente a spese della Cecoslovacchia a Roma per 2-1. Il «Corriere della sera» scrisse: «Entusiasmati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo». E nel sommario di questo titolo a tutta pagina c’erano le seguenti parole: «La vibrante partita finale con i cecoslovacchi: Mussolini premia tra le acclamazioni della folla le valorose competitrici e la squadra tedesca terza classificata». Quanto alla «Stampa», titolò così: «I calciatori italiani alla presenza del Duce conquistano il campionato del mondo: dopo un epico ed appassionante incontro con i rivali cecoslovacchi (2-1)».
Al di là dello sfruttamento che il regime fece della vittoria e dell’intera manifestazione (un anno prima, la presidenza della Federcalcio era passata da Leandro Arpinati al generale della milizia Giorgio Vaccaro, per via di giochi di potere vicinissimi a Palazzo Venezia), al di là della facile mercificazione nazionale dell’evento, ci fu sostanzialmente del buon gioco, ci fu una preparazione abbastanza scientifica, ci fu il premio giusto all’impegno, al pathos, allo stress, come si direbbe adesso. Il ritiro collegiale fu tenuto prima in una località chiamata Alpino, in Piemonte, presso il Lago Maggiore, sotto il monte chiamato Mottarone, poi a Roveta, tra Firenze e Pisa.
Pozzo parlò molto di valori patrii, di necessità di aggredire gli avversari. Il rituale del «collegiale» fu in fondo quello di adesso, con grosso impegno culinario, grosso cicaleccio giornalistico.
Il torneo ebbe inizio il 27 maggio, con sedici finaliste, espresse da dodici gruppi eliminatori, che avevano scremato le trentadue nazioni iscritte. Non c’era l’Uruguay, campione mondiale in carica, assente per ragioni finanziarie, non c’era l’Inghilterra, che ancora non accettava, nel proprio disegno aristocratico, questo tipo di sfide.
Otto diverse città d’Italia ospitarono le partite, si registrarono i primi spostamenti etnici dovuti al dio calcio, ci furono partite tremende e partite semplicissime. Con l’Italia (7-1 sugli Stati Uniti) entrarono nei quarti di finale Svezia, Spagna, Germania, Cecoslovacchia, Ungheria, Austria. Rileggetevi l’elenco, non trovate nessuna squadra extraeuropea.
Tutti i quarti di finale, legati alla formula dell’eliminazione diretta, furono drammatici. Più di tutti quello fra Italia e Spagna. L’Italia, nel primo confronto, arrivò al pareggio, con un gol probabilmente irregolare segnato da Ferrari, mentre Schiavio ostacolava il celebre portiere Zamora.
La partita venne ripetuta il giorno dopo, Vittorio Pozzo operò qualche cambio, la Spagna sostituì addirittura Zamora. Si parlò di polso slogato, si sussurrò di pressioni italiane con matrice politica, perché il portiere troppo bravo non venisse schierato.
La partita di ripetizione venne vinta dall’Italia per 1-0. Due giorni dopo ci furono le semifinali, Italia-Austria a Milano e Cecoslovacchia-Germania a Roma.
Cinquantamila spettatori a San Siro, portando 811.526 all’incasso. applaudirono il successo italiano, dovuto a un complicato gol, fatto per un terzo da Schiavio, un terzo da Meazza e un terzo da Guaita. Alla fine di quell’azione, mezza squadra italiana e mezza squadra austriaca si ritrovarono dentro la rete, che ospitava davvero un po’ troppa gente. Fu comunque un successo tutto sommato legittimo per gli italiani, che poi incontrarono a Roma i cecoslovacchi, i quali avevano liquidato per 3-1 i tedeschi.
Quattro treni speciali arrivarono a Roma dalla Cecoslovacchia, otto da tutto il resto dell’Italia. Incasso di 700.000 lire, inferiore a quello di San Siro. Partita bellissima dal punto di vista emotivo, primo gol cecoslovacco, palo che impedì ai nostri «nemici» di raddoppiare, gol del pareggio segnato da Orsi, tempi supplementari. In questo supplemento di partita Guaita, emarginato da Pozzo che lo aveva messo all’ala destra, scoprendolo stanco, servì a Schiavio, che lo aveva sostituito al centro dell’attacco, un pallone prezioso: tiro di Schiavio, palo interno e rete, nonostante il tuffo del portiere cecoslovacco Planicka, che la mitologia dell’epoca reputava secondo al solo Zamora.
Mussolini lì a premiare i vincitori, un grosso rituale di festeggiamenti, sul campo e subito dopo, e la sensazione, abbastanza legittima, di essere, sia pure con l’aiuto di argentini e uruguaiani, i migliori del mondo.
Quattro anni dopo, con un’Italia politicamente più in difficoltà, con i campionati del mondo organizzati nella Francia che cominciava a esserci ostile, anche per l’eco che avevano le proteste dei fuoriusciti antifascisti, l’Italia fu chiamata a confermare il suo titolo.
Vittorio Pozzo era sempre il commissario tecnico, l’ossatura della squadra era cambiata, perché l’Italia aveva, se così si può dire, abbandonato la Juventus, che nel 1935 aveva concluso il suo quinquennale periodo di dominazione in Italia e non poteva più costituire l’ossatura piena della Nazionale.
Prima di addentrarci nei dolci misteri dell’edizione 1938, è bene ritornare ancora per un poco sull’edizione 1934. Già abbiamo detto degli incontri, a grandi linee. È necessario però esaminare, e con la lente della storia anziché con il fondo di bicchiere della cronaca, la composizione della squadra italiana.
Lasciamo perdere il match di qualificazione con la Grecia (4-0 il 25 marzo di quel 1934), che ha assunto un particolare valore statistico soltanto perché vi giocò per un tempo un uomo che doveva poi essere famoso nel calcio italiano didascalico del dopoguerra, cioè Nereo Rocco.
Il vero e proprio campionato del mondo 1934 cominciò con l’incontro fra l’Italia e gli Stati Uniti, il 27 maggio a Roma. Ma se gli Stati Uniti si erano limitati a schierare un oriundo italiano, Donelli, centravanti, l’Italia aveva allineato tre sudamericani, per la precisione Monti e Orsi della Juventus, e Guarisi della Lazio.
Nel primo dei due incontri con la Spagna, l’Italia «adoperò» i sudamericani Monti e Orsi, già adoperati prima, e un altro sudamericano, Guaita della Roma. Nella ripetizione, ancora Orsi, ancora Monti, ancora Guaita, e inoltre De Maria. Nella semifinale con l’Austria, ancora Monti, ancora Guaita, ancora Orsi. Infine, nella finale con la Cecoslovacchia, Monti, Guaita e Orsi.
L’interpretazione diciamo pure politica di questa utilizzazione fu, ovviamente, assai positiva in quel periodo. Gli oriundi, i figli o nipoti di italiani, vennero chiamati «rimpatriati», e il regime fascista si riappropriò della loro residua italianità, facendola levitare e lievitare, dilatandola con opportune campagne. In pratica questi sudamericani, prevalentemente argentini, rientrati nella terra dei loro avi, furono gli elementi politicamente ideali, dal punto di vista del regime, per certificare una rinascita o una nascita dell’Italia, una possibilità del nostro paese di ospitare gente che in fondo, qualche anno prima, se ne era dovuta andare via.
Si deve dire, obiettivamente, che non venne mai sollevata la minima eccezione di italianità nei riguardi di questi personaggi, né in Italia, né fuori Italia. I vari De Maria, Guaita, Monti, Orsi e Guarisi furono recepiti da tutto il calcio mondiale come italiani al cento per cento.
Curiosamente, giocò una partita nell’Italia che doveva diventare campione del mondo anche un «rimpatriato», se si vuole, dalla Francia, Felice Placido Borel, conosciuto anche come Borei II, attaccante della Juventus, nato a Nizza Marittima, cresciuto a Torino, senz’altro italianissimo.
Il calcio comunque dettava già allora i suoi grandi temi internazionali, aveva già allora una ecumenicità che tuttavia la stampa cieca di partito non riusciva a far rilevare. Si andava ancora avanti nel nome dell’«Italia-Italia», l’Austria guidata da Hugo Meisl era ancora una squadra nemica (fra l’altro, quattro mesi prima del Mondiale, a Torino, ci aveva umiliati con un 4-2), e in sostanza si preferiva il sospiro da strapaese, non importa se permesso, rinforzato dagli oriundi, al grande respiro internazionale. Ma veniamo all’edizione del 1938. L’Italia si presentava con un’altra caratura calcistica e politica. Quella calcistica si era fatta assai pregiata: gli azzurri avevano vinto la Coppa Internazionale nel 1935 e le Olimpiadi di Berlino nel 1936. Calcisticamente parlando, l’Italia aveva meritato, se così si può dire, il titolo mondiale 1934 dopo averlo conquistato.
Dal punto di vista politico, e ne abbiamo già accennato, era invece un’Italia in cui si violavano i diritti dell’uomo, dove si combatteva la democrazia, dove si negavano anche le libertà primarie, quella che delegava al football il compito di fornire in giro una buona immagine di se stessa.
Ricordiamo che il 1 settembre 1939 le truppe del Terzo Reich avevano invaso la Polonia, dando così inizio alla seconda guerra mondiale. Ricordiamo che nel 1938 l’Italia non era certamente in odore di «santità» diplomatica, con il flirt già in atto tra Mussolini e Hitler.
Vittorio Pozzo, commissario tecnico dell’Italia calcistica, in salute buona, addirittura assurda, abnorme, rispetto alla salute psicologica della nazione tutta, era profondamente preoccupato alla vigilia del campionato del mondo 1938, organizzato in terra di Francia, dove i fuoriusciti italiani, perseguitati dal fascismo, avevano un’ottima udienza.
La prima partita, contro i norvegesi, in programma a Marsiglia, sembrava comunque un incontro ideale per permettere una facile avanzata nella fase finale, magari con uno show calcistico condito da molti gol, e per procacciarsi simpatie. Però la squadra-mosaico italiana, con giocatori provenienti da sette club diversi (Lucchese, Roma, Juventus, Bologna, Triestina, Ambrosiana, Lazio), penò assai contro i norvegesi che non godevano di una seria quotazione alla borsa del football mondiale. A sette minuti dalla fine, la poverissima Norvegia pareggiò il gol segnato dall’ala sinistra Ferraris II per noi dopo due minuti dal fischio d’inizio. A un minuto dalla conclusione, il centravanti norvegese Brynildsen, regolarmente gigantesco e biondo, sbagliò un gol fatto davanti al nostro portiere Olivieri. Si arrivò ai tempi supplementari, Piola ci qualificò con un suo gol. Questo Silvio Piola, lombardo di Robbio Lomellina, ma, dal punto di vista dell’estrazione calcistica, piemontese di Vercelli, doveva diventare uno dei più grandi personaggi del calcio italiano.
La sera della faticatissima qualificazione contro la Norvegia, Vittorio Pozzo decise di cambiare albergo per gli azzurri. Li trasportò ad Aix-en-Provence, abbandonando l’hòtel di Marsiglia, meta di troppi visitatori; fece alcune operazioni chirurgiche all’interno della squadra (Foni al posto di Monzeglio, nel ruolo di terzino; Biavati e Colaussi al posto di Pasinati e Ferraris II, nel ruolo di ala), predispose con l’attenzione di un superiore di convento l’eventuale trasferimento a Parigi, prenotando un albergo tranquillo, e insomma propiziò un certo positivo assestamento psicologico e anche fisico della squadra azzurra in vista dell’incontro con i francesi, il 12 giugno.
Erano i quarti di finale, 1-0 dopo sette minuti per l’Italia con Colaussi, pareggio francese, due gol di Piola nella ripresa. L’Italia era in semifinale.
Il sorteggio assegnò all’Italia il Brasile che si era portato avanti superando la Polonia per 6-5 nei tempi supplementari e la Cecoslovacchia per 2-1, dopo la ripetizione del primo incontro conclusosi in pareggio.
Il Brasile aveva patito, in queste partite, l’infortunio di Leonidas, il suo centravanti di colore, l’uomo più forte della squadra, intanto che la Cecoslovacchia aveva perduto il suo grande portiere Planicka e il suo grande mediano Nejedly.
Praticamente le due squadre più quotate si autoeliminarono. Il Brasile approdò alla semifinale con l’Italia privo di Leonidas, che forse avrebbe potuto giocare, ma che venne consigliato al riposo con un atto di presunzione (i brasiliani erano certi di eliminarci e di arrivare in finale, e volevano riservare in salute piena la loro «perla nera» per l’incontro decisivo), noi vincemmo.
Colaussi segnò il primo gol all’11’ del secondo tempo, Meazza trasformò in gol un rigore per un fallo di Domingo sul nostro Piola: insomma l’Italia arrivò alla finale contro l’Ungheria che si era qualificata facilmente, disponendo delle Indie Olandesi, della Svizzera e della Svezia.
I magiari erano in quel momento, anzi in quegli anni, gli esponenti migliori del calcio danubiano, un calcio danzato, un calcio spettacolare e, mentre ancora non erano stati predisposti validi strumenti difensivi, anche efficiente. Ma diciamo della finale. Pareggio (1-1) dopo otto minuti di gioco, dopo le reti di Colaussi e Titkos. Poi 3-1 per noi, con Piola e ancora Colaussi, 3-2 per un gol dell’ungherese Sarosi, 4-2 per un gol di Piola, ufficiosamente consacrato il miglior giocatore di quell’edizione della Coppa Rimet. E fu il titolo-bis.
La finale era stata molto facile. L’incontro chiave di quell’edizione del campionato mondiale era stato quello di semifinale contro il Brasile, che aveva avuto, prima di affrontare 1 Italia, un osservatore-spione legale e speciale nella persona di Giampiero Combi, portiere della rete azzurra quattro anni prima e inviato speciale di Pozzo per conoscere forze e debolezze degli avversari sudamericani. Lo stesso Brasile aveva affrontato la semifinale contro di noi con sicumera, più che con sicurezza. Già allora si parlava di premi: l’equivalente di dieci milioni di adesso e un villino per ogni giocatore brasiliano, se fosse diventato campione e mondo. L’incontro con il Brasile (torniamo indietro) fu epico, comico, picaresco, patetico, e ancora adesso i pochi testimoni oculari viventi gli appiccicano aggettivi speciali. Meazza, a esempio, tirò il rigore, praticamente decisivo per la definizione del punteggio, tenendosi i calzoncini con le mani perché si era appena strappato l’elastico. Nell’ultimo minuto, lo stesso Meazza si mise a palleggiare proprio alla sudamericana, anzi alla brasiliana, per perdere tempo.
E ancora: il trasferimento da Marsiglia a Parigi dove si doveva disputare la finale, avvenne in treno, nella notte, ma non in vagone letto, con i calciatori in odore di titolo mondiale impegnati (si deve dire così) a dormire uno addosso all’altro, usufruendo dei soli cinque posti-letto reperiti.
Funzionarono anche alcune cabale particolari di Vittorio Pozzo, meticoloso e superstizioso nello stabilire, a esempio, i posti a tavola, gli accoppiamenti nelle camere di albergo. Si deve dire che anche il ritiro aveva ricalcato scrupolosamente, in omaggio più che altro alla superstizione, i luoghi e i tempi del 1934: prima all’Alpino, sul Mottarone, poi a Roveta, sui colli toscani.
Ma Pozzo non tentava soltanto la via dei ricorsi storici o delle superstizioni alimentate, assecondate. A esempio, impedito dai regolamenti di allora a trasmettere i suoi ordini dalla panchina al terreno, riuscì a organizzare un servizio di staffetta con Luigi Burlando, ex pallanuotista genovese, suo uomo di fiducia. In pratica, anticipo, con molta discrezione, la moda attuale dei tecnici urlanti dai bordi del campo.
Il premio per gli azzurri fu consistente, anche se misterioso. Ufficialmente il governo di Mussolini offrì una settimana di soggiorno a Parigi alla squadra che aveva rivinto il campionato del mondo, ma il giorno dopo la finale di Parigi contro l’Ungheria, tutta la squadra era già in treno, alla volta dell’Italia. Vittorio Pozzo teneva sottobraccio la Coppa Rimet.
Si deve dire che, degli uomini artefici di quel titolo mondiale, uno solo non era nato in Italia, per la precisione Michele Andreolo, centromediano, in forza a Bologna, ma proveniente da Montevideo, Uruguay. Il resto era produzione casareccia, diciamo pure ruspante. Meno classe, nella squadra 1938, che nella squadra 1934. Ma più determinazione, più atletismo.
Dei grandi di quattro anni prima, erano «superstiti» Ferraris II, Monzeglio e Meazza. Monzeglio era, fra l’altro, allenatore di tennis (allenatore sui generis: più che altro compagno di partita) dei figli di Mussolini, il quale ricevette a Palazzo Venezia gli azzurri, obbligandoli (è il caso di dirlo) a posare per la foto ufficiale con una buffa divisa: camicia azzurra enorme, da boy di rivista, calzoni bianchi, bustina bianca.
L’anno dopo, anche in Italia si cominciò a parlare di guerra.
I rapporti tra il calcio e la situazione bellica, nel suo insieme, in Italia, non sono mai stati, non diciamo chiariti, ma neppure indagati. Si è «accettato» che la squadra più forte di quel periodo, il Torino, godesse di una speciale protezione, con i suoi atleti ufficialmente operai della Fiat e quindi al riparo dai provvedimenti di deportazione in Germania.
Una partita a Torino, fra Torino e Juventus, vide un regolamento di conti fra repubblichini e partigiani, con raffiche di mitra da una parte all’altra delle gradinate. Ma nell’insieme l’attività calcistica, in fondo sospesa per poco, riuscì sempre a conservare la sua asetticità.
La ripresa piena del calcio, dopo la fine della guerra, fu considerata un fatto squisitamente naturale. Riprese l’attività anche la Nazionale italiana, mentre il football internazionale, riunito in congresso il 25-26 luglio 1946, decise di «reagire» allo shock della guerra rilanciando immediatamente il campionato del mondo. Anzi, proprio in quell’occasione si decise ufficialmente di dare alla coppa il nome di Jules Rimet. Prima tutti la chiamavano così, ma la dizione non era ufficiale.
L’Europa, bontà sua, ebbe il coraggio di dichiararsi prostrata, economicamente e non solo, dagli eventi bellici, e al Brasile fu facile ottenere l’organizzazione della Coppa Rimet 1950.
La partecipazione alla Coppa stessa patì di vari impedimenti speciali: la Germania non partecipò perché tutto lo sport tedesco era «sospeso» dalle organizzazioni internazionali. I paesi dell’Est Europa, impegnati nel tentativo di costruire un socialismo sulle macerie, non avevano ufficialmente tempo, voglia e denaro per impegnarsi calcisticamente a migliaia di chilometri di distanza.
Per fortuna che l’Inghilterra, anzi la Gran Bretagna, e con le sue quattro federazioni (inglese, scozzese, irlandese del nord e gallese), scoprì la validità della manifestazione. I maestri inglesi, inventori del calcio, si degnavano finalmente di prendere parte alla massima competizione mondiale.
L’Italia era qualificata di diritto, come campione del mondo in carica. Annullate per ragioni belliche le edizioni del 1942 e del 1946, la Coppa Rimet 1950 si allacciò direttamente alla manifestazione mondiale 1938.
Esentata dalle qualificazione, l’Italia trovò tuttavia un avversario spaventoso, decisivo, in se stessa. Si trattò, peraltro, di una operazione psicologica negativa, ricca, se così si può dire, di tutte le attenuanti.
Il 4 maggio 1949 la squadra che dominava il campionato italiano da cinque edizioni, la squadra chiamata Grande Torino, fu distrutta in un incidente aereo sulla collina di Superga. L’aereo che riportava i giocatori granata nella loro città, dopo un’amichevole giocata in Portogallo, si schiantò contro la collina. Morirono diciotto giocatori, fra i quali quelli che costituivano l’ossatura della Nazionale azzurra: basti dire che nel 1947, giocando e vincendo contro l’Ungheria proprio a Torino, Vittorio Pozzo aveva mandato in campo una squadra formata da dieci calciatori del Torino e da uno della Juventus, il portiere Sentimenti IV.
La fine del Grande Torino ebbe il suo peso nella fine calcistica dell’Italia nell’edizione 1950 della Coppa Rimet. Il nostro calcio era ancora devastato dal dolore, dal ricordo, dalla paura.
Per andare in Brasile, si rinunciò all’aereo, si scelse la nave. Si chiamava Sises il vascello che portò i nostri calciatori da Napoli a Rio de Janeiro. Pozzo aveva «staccato», dopo l’umiliazione della nostra squadra all’olimpiade di Londra 1948, dove avevamo scoperto la forza del calcio danese, e una trimurti, formata da Ferruccio Novo, il presidente del Grande Torino, da Aldo Bardelli, dirigente del Livorno, consigliere federale e giornalista, e da Roberto Copernico, gentleman torinese, presiedevano ai destini azzurri.
Nell’insieme il nostro calcio, nonostante la tragedia del Torino, sembrava godere di una certa salute. Tre giocatori stranieri per squadra garantivano lo spettacolo, avevano provveduto diligentemente a saccheggiare la Danimarca e, di già che c’eravamo, anche un po’ la Svezia. I risultati della Nazionale, nonostante l’impoverimento per la scomparsa dei giocatori del Grande Torino, apparivano abbastanza confortanti.
Tuttavia, quindici giorni di navigazione, una preparazione sommaria in patria, una preparazione allucinante sulla nave (dopo pochi giorni erano caduti in mare tutti i palloni a disposizione per fare un po’ di calcio sul ponte), tutto contribuì a porre le premesse per la nostra disfatta.
Sulla traversata dell’Atlantico, fatta, vissuta, patita, dalla Nazionale azzurra a bordo del Sises, si potrebbe scrivere un libro. Tutto il rituale delle grandi crociere venne rispettato, comprese le goliardate al passaggio dell’equatore e le grandi abbuffate.
A Rio de Janeiro, la mattina del 19 giugno, dopo quindici giorni di navigazione, il Sises attraccò a una banchina affollata di italiani. Duecentomila nostri connazionali erano affluiti al porto.
I giocatori azzurri furono trasferiti subito a San Paolo, sede del nostro girone, che ci opponeva alla Svezia e al Paraguay.
Il 19 giugno, contro la Svezia, una squadra italiana abbastanza mosaicata cominciò e concluse la sua avventura mondiale. In vantaggio per 1-0 con un gol di Carapellese, segnato nel delirio degli italiani di San Paolo, i nostri furono pareggiati dallo svedese Jeppson, superati dallo svedese Anderson.
Lo stesso Jeppson segnò il terzo gol per gli svedesi. Passammo a 3-2 con Mucinelli, piccola ala destra, colpimmo un palo con Carapellese all’ultimo minuto, perdendo 3-2, fummo praticamente messi fuori dal campionato del mondo. Ci sarebbe voluta una vittoria del modesto Paraguay contro la Svezia lanciatissima, e invece fu un pareggio. Dal punto di vista morale ci togliemmo lo sfizio di battere (2-0, reti di Pandolfini e Carapellese) il Paraguay, giocando anche bene, il che contribuì ad accrescere i nostri rimorsi.
Lo scoppio della guerra di Corea riuscì a ridurre, sui giornali, lo spazio riservato alle esecrazioni, per altro doverose, della squadra azzurra.
Si deve dire che la Svezia era stata mutilata da noi dei vari Gren, Nordahl e Liedholm, ma che era riuscita a esprimere talenti di ricambio piuttosto validi, così prenotando, per i suoi giocatori, le bancarelle migliori del nostro mercato.
Probabilmente è da far datare a quel 1950 la nascita del moralismo calcistico del giornalismo italiano. Scoprimmo la nostra approssimazione, la nostra spocchia, ci sentimmo schiavi di un complesso di inferiorità che ci portava a patire gli stranieri, a pagarli a peso d’oro e a farci fucilare, nei confronti diretti, dal loro piombo, e insomma avviammo un esame di coscienza che non è ancora finito e che non finirà mai.
Intanto, il campionato del mondo andava avanti. La formula complessa, studiata dagli organizzatori brasiliani per giocare numerosi incontri, moltiplicare gli incassi e ammortizzare le grosse spese per la costruzione dello stadio Maracanà di Rio, il più grande del mondo, duecentotremila posti, sembrava favorire il Brasile.
La squadra carioca e paulista vinceva il suo girone, su Jugoslavia, Svizzera e Messico, e accedeva al girone finale, insieme con la Spagna, l’Uruguay e la Svezia, qualificati dagli altri raggruppamenti.
Si trattava di assegnare il titolo mondiale con una formula del girone all’italiana di sola andata. Il Brasile e l’Uruguay arrivarono all’ultimo incontro con i locali in vantaggio di un punto. Bastava ai padroni di casa un pareggio, ci fu immediatamente la promessa di una vittoria, con il gol del brasiliano Friaca al secondo minuto del secondo tempo. Vittoria anche nel confronto diretto, oltre che nella classifica finale.
Ma venti minuti dopo, Schiaffino, l’uruguaiano di origine li pareggiò il gol brasiliano. Attacchi del Brasile, gol in contropiede al 28’ dell’Uruguay, segnato da Ghiggia, anche lui annunciato come oriundo (o presunto tale) quando sarebbe venuto in Italia.
Al Maracanà non venne suonato nella premiazione l’inno uruguaiano, la banda se n’era andata alla fine del match, i suoi componenti si erano detti affranti dal dolore.
Ispirato in attacco da Ghiggia, a centro campo da Schiaffino e in difesa da Varela, l’Uruguay era riuscito nell’impresa «folle» di sconfiggere al Maracanà un Brasile che si era presentato all’ultimo incontro forte di un 7-1 sulla Svezia e di un 6-1 sulla Spagna (di contro, l’Uruguay aveva pareggiato con la Spagna e aveva faticato a battere la Svezia).
Quel giorno, a Rio de Janeiro e in tutta la nazione, fu decretata una sorta di lutto. Qualcuno nominò, a proposito della soluzione finale della Coppa Rimet, a proposito del tipo di gioco che aveva premiato l’Uruguay e condannato il Brasile, la parola magica e intanto quasi blasfema: catenaccio. Un uomo adibito a puri compiti difensivi-distruttivi, senza problemi di marcatura diretta. La rinuncia al gioco, pur di non lasciar giocare.
Comunque non si parlò di furto, ma semplicemente di accorta tattica di gioco. Noi italiani riuscimmo ad assimilare la lezione uruguaiana per il nostro campionato. Due anni dopo, l’Inter guidata da Foni, ex campione del mondo, vinceva due scudetti consecutivi, praticando il calcio difensivo che, in occasione della Coppa Rimet 1950, aveva dato all’Uruguay, peraltro fatto grande della classe e salute di elementi come Varela, Schiaffino e Ghiggia, il titolo mondiale.
In quel 1950 l’Uruguay raggiungeva l’Italia a quota due nel numero di vittorie: la Coppa Rimet sembrava alla portata degli uruguaiani in maglia celeste o degli italiani in maglia azzurra, visto che il regolamento prevedeva l’assegnazione definitiva alla nazione che l’avesse vinta per tre volte, anche non consecutive.
Per quel che riguarda l’Italia, ci pare giusto aggiungere un’annotazione particolare, diciamo pure personale, all’edizione 1950 della Coppa Rimet. Fu l’ultima volta, quella, in cui la nostra Nazionale difettò di informazioni stampa intorno a lei. La lunghezza e il costo del viaggio avevano limitato assai gli spostamenti dei cosiddetti inviati speciali.
La squadra fu sprovvista, per l’ultima volta, di quello che sarebbe poi diventato un alibi: e cioè l’assillo creato dai rappresentanti della stampa, soprattutto di quella scritta, poi anche di quella elettronica, cioè di quella radiotelevisiva. Quattro anni dopo per l’edizione mondiale organizzata in terra elvetica, ci sarebbe state addirittura il lancio delle trasmissioni televisive in diretta
Per l’edizione 1954 ci qualificammo abbastanza facilmente, battendo l’Egitto 2-1 al Cairo e 3-0 a Milano, in un tremendo giorno d’inverno. Il commissario tecnico era Lajos Czeizler, mezzo ungherese, mezzo svedese, che riuscì a farsi tutto italiano, nella simpatia e anche negli errori.
Dal 1950 al 1954 il nostro calcio era profondamente mutato, sia per l’arrivo di numerosi giocatori stranieri, sia per le confusioni di vertice. La Nazionale per un certo periodo fu affidata addirittura a tre tecnici, cioè Beretta, un armaiolo bresciano, Busini, un dirigente del Milan, e Combi, dirigente della Juventus e vincitore del titolo mondiale del 1934. La squadra azzurra conobbe tutti gli esperimenti. Tornò in Nazionale addirittura Piola, trentottenne, per un incontro a Firenze con l’Inghilterra, incontro che riuscimmo a pareggiare (1-1).
Ci umiliò nel 1953 l’Ungheria per 3-0, nella partita inaugurale dello Stadio Olimpico in Roma. Giulio Andreotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, divenne celebre presso gli sportivi per il veto messo all’ingresso di altri stranieri nel nostro calcio (il provvedimento tuttavia non riguardava gli oriundi, e dal Sudamerica il flusso continuò).
Quanto alla squadra azzurra, erano gli anni del blocco della Fiorentina, erano i tempi delle affermazioni individuali di Giampiero Boniperti, della Juventus, come massima luce tecnica del nostro calcio. Non si era ancora pensato di fare ricorso massiccio agli assi sudamericani naturalizzati, agli oriundi figli di italiani; gli arrivi, sino a quei tempi, avevano riguardato soprattutto elementi del Nordeuropa, assolutamente non italianizzabili. Gli indigeni avevano da noi un ottimo spazio.
Lajos Czeizler scelse Vevey, sulle rive del lago Lemano, come quartier generale della squadra italiana, che stava nel girone con gli svizzeri padroni di casa, con l’Inghilterra e col Belgio, ma che, designata testa di serie insieme con gli inglesi, era «esentata» dall’incontrarli per via della formula bizzarra di allora.
Gli inglesi «reggevano» la testa di serie in virtù della loro antica aristocrazia, non certo di quanto combinato nell’esordio (1950) al primo loro campionato del mondo, quando erano stati eliminati (gol in contropiede, 1-0) dall’armata brancaleonica degli Stati Uniti.
Per il nostro incontro d’esordio, c’era la Svizzera. Noi giocavamo ancora col sistema, proprio mentre il catenaccio, lanciato ad altissimo livello dall’Uruguay nel 1950 e adottato benissimo dalle nostre squadre di club, sembrava il verbo nuovo, sembrava soprattutto il marchingegno più valido. Alla fine del primo tempo con gli svizzeri eravamo sull’1-1, col pareggio faticosamente raggiunto da Romperti, quasi in chiusura di quella prima frazione. Gol del 2-1 conclusivo per gli elvetici nella ripresa molto all’arbitro brasiliano Viana, un’etichettatura di protestatori a ogni costo che non ci giovò per il prosieguo del torneo.
Superammo poi il Belgio per 4-1 e ci ritrovammo alla fine del girone alle spalle degli inglesi (3 punti), alla pari degli svizzeri (2 punti ciascuno).
La formula prevedeva uno spareggio fra le due squadre a pari punti. Si giocò a Basilea e Czeizler presentò una squadra inedita, con esordienti come Viola, portiere della Juventus, e Pandolfini. mezzala della Fiorentina, con il mediano fiorentino Segato schierato all’attacco, con i giocatori confusi tatticamente. Fu un 4-1 per gli svizzeri. Ci televidero in tutta Europa, l’unico nostro gol fu segnato da Nesti, un mediano; il torneo mondiale andò avanti senza di noi.
Fu la più drammatica edizione della Coppa Rimet. Il Brasile, deciso a farsi sommamente pratico dopo la tremenda lezione del 1950, quando l’Uruguay aveva spento non solo il Maracanà, non solo tutta Rio, ma tutta una nazione (si parla di decine di suicidi, in quei giorni), il Brasile dicevamo si misurò nei quarti con l’Ungheria, quella che ci aveva umiliati a Roma, quella dei grandi Kocsis e Puskas.
Vinsero i magiari per 4-2, benché nell’Ungheria mancasse proprio Puskas, azzoppato in un incontro precedente dal tedesco occidentale Liebrich. Ci fu rissa in campo, ci fu rissa soprattutto fuori, negli spogliatoi bottiglie vennero spaccate sulle teste, lo stesso Puskas entrò in azione. Il Brasile venne eliminato, il calcio sudamericano si incontrò con quello magiaro nuovamente in semifinale, Uruguay contro Ungheria.
Fu 2-0 quasi subito per i magiari, poi 2-2, poi due pali per gli uruguaiani, poi due gol di testa di Kocsis in contropiede, con numeri di alta acrobazia. In conclusione, ancora 4-2 per 1 Ungheria, alla fine di una delle più belle partite nella storia del calcio di tutti i tempi.
In finalissima i magiari ritrovarono la Germania Ovest, che aveva battuto per 8-3 nelle prime qualificazioni. In campo anche Puskas, con la caviglia ancora malandata. Doveva essere una formalità per la grande Ungheria, che dopo otto minuti vinceva già per 2-0, con reti di Puskas e di Czibor. Ma nella ripresa strane energie pervasero i tedeschi, mentre una stanchezza per niente strana, visto il grande dispendio di forze nel quarto di finale contro il Brasile e nella semifinale contro l’Uruguay, invase gli ungheresi. I tedeschi pareggiarono al 18’, passarono in vantaggio a 3-2 al 39’ con il gol, inevitabilmente definito storico, dell’ala Rahn. Alla fine fu 3-2 per i tedeschi, così campioni del mondo.
All’Ungheria restò la soddisfazione della cosiddetta vittoria morale, soddisfazione che in un certo senso crebbe e in un altro senso si permeò di spaventoso e acre rimpianto quando, pochi mesi dopo, la squadra tedesca pressoché al gran completo cadde vittima di un’epatite che la pur sommaria medicina sportiva di quel tempo ascrisse a pratiche «dopanti».
La spiegazione dello straordinario secondo tempo dei tedeschi, guidati da Sepp Herberger, parve dunque chimica. Ma non ci fu assolutamente inchiesta ufficiale, non ci fu revoca del titolo, la Germania rimase campione del mondo.
Si deve dire che in quel 1954 pochi ravvisavano esattamente l’importanza del fenomeno televisivo, che pure aveva preso possesso del Campionato del Mondo di calcio. La stampa scritta, non solo in Italia, faceva resistenza, e anziché completare con le sue informazioni i dati assolutamente di fatto forniti dalle immagini, cercava di predicare una verità sua, di mandare avanti un suo vangelo sottile, anche polemico. Le riprese, allora, avvenivano su larghe porzioni di campo, i giocatori apparivano molto piccoli, la qualità anche tecnica delle trasmissioni non era buona. Non c’era il ralenti. La stampa scritta sosteneva che la ripresa televisiva non permetteva di fornire la giusta visione di un campo di calcio. Il giocatore in possesso del pallone non poteva, a esempio, essere criticato per l’errore che faceva non liberandosi del pallone stesso e non inviandolo a un compagno smarcato: questo per la semplice ragione che sul teleschermo il compagno smarcato non appariva.
Ma più che sviluppare questi concetti di un certo valore, la stampa scritta resisteva all’evento televisivo in nome di un trombonismo dei suoi componenti, nel nome di una verità, e una sola, da spezzare, la sua, insieme stalattite e stalagmite di una caverna in cui il giornale «di carta» doveva essere l’unica luce.
Alla fase finale del campionato mondiale del 1958 l’Italia non prese parte. Per la semplice ragione che non si qualificò. La nostra Nazionale si era tolta, nel 1955, lo sfizio di battere a Stoccarda, per 2-1, la Germania campione del mondo e campione anche di epatite. Poi la squadra azzurra aveva vivacchiato, con risultati nel complesso abbastanza positivi, grazie anche all’uso intelligente del blocco della Fiorentina, che stava praticando il miglior calcio in Italia, o almeno il calcio più redditizio. Pervenne alla Nazionale anche Michelangelo Montuori, argentino cresciuto in Cile, figlio o nipote di italiani (così almeno si disse), e capacissimo di commuoversi autenticamente nell’ascoltare l’inno di Mameli.
Alla vigilia della Coppa Rimet 1958, arrivarono in Italia importantissimi giocatori dall’Argentina: addirittura 1 intero trio d’attacco della Nazionale biancoceleste che aveva vinto il campionato sudamericano si trasferì dalle nostre parti: Omar Sivori alla Juventus, Humberto Maschio al Bologna, Valentin Angelillo all’Inter. Sivori e Angelillo avevano ventidue anni, Maschio ne aveva ventitré. Si cominciò a parlare di sistemazione di questi oriundi italiani nella Nazionale. Il commissario tecnico azzurro era Alfredo Foni, ex campione del mondo, grande propugnatore del catenaccio, con il quale aveva vinto due scudetti, guidando l’Internazionale di Milano.
Foni abbondò in esperimenti. Nell’attacco azzurro arrivò il sudafricano Firmani, arrivò l’argentino Pesaola, arrivò l’uruguaiano Ghiggia, arrivò l’altro uruguaiano Schiaffino.
Le qualificazioni per la fase finale della Coppa Rimet 1958 ci avevano assegnato un girone relativamente facile, con il Portogallo e l’Irlanda del Nord. Nella partita inaugurale di quella fase di qualificazione, sconfiggemmo all’Olimpico di Roma l’Irlanda del Nord per 1-0, con gol su punizione del difensore fiorentino Cervato.
Un pareggio a Lisbona contro il Portogallo avrebbe significato il punto magico, decisivo: ma incassammo tre gol a zero. Restituimmo al Portogallo l’identico punteggio a Milano, e a questo punto la sfida decisiva divenne quella fra noi e l’Irlanda del Nord.
Dal momento che avevamo sconfitto il Portogallo con due uruguaiani (Ghiggia e Schiaffino) e un argentino-cileno (Montuori) in attacco, per cercare di sconfiggere gli irlandesi inserimmo, sempre davanti, anche il brasiliano Da Costa.
Ma siamo già all’incontro ufficiale, mentre prima ce n’era stato uno amichevole (si fa per dire) con la stessa Irlanda del Nord, un incontro che in seguito sarebbe stato ricordato come la grande occasione perduta. Era accaduto, il 4 dicembre 1957, che l’arbitro ungherese Zsolt e i suoi due guardalinee non fossero arrivati in tempo a Belfast per la partita cosiddetta decisiva. Italiani e irlandesi stabilirono di giocare ugualmente il match in amichevole. Finì 2-2, finì soprattutto a botte.
La pratica irlandese venne messa da parte, ci fu (già detto) la partita del 3-0 nostro sul Portogallo e poi si dovette tornare a Belfast per l’incontro ufficiale.
Non si recriminava ancora troppo su quel 2-2 «non accettato» (aveva arbitrato un irlandese, Mitchell), si pensava che si sarebbe comunque vinto il match «vero», quattro sudamericani su cinque potevano, anzi dovevano garantire al nostro attacco la fantasia necessaria per scardinare il bunker britannico. Fra l’altro gli irlandesi non potevano disporre del loro portiere bravo, anzi mitico, Gregg, trattenuto in Inghilterra da impegni del campionato inglese, in cui lui era calciatore «mercenario», come molti del suo paese.
L arbitro era sempre quello Zsolt ungherese, questa volta arrivato in tempo. Il pubblico fu impeccabile, era lo stesso pubblico che un mese prima aveva invaso il campo picchiando gli azzurri, venendo picchiato dagli azzurri, offrendo al nostro centromediano Ferrano il martirologio e l’appellativo storico di «leone di Belfast».
Compostissimo, il pubblico applaudì il vantaggio degli irlandesi per 2-0, li rincuorò quando Da Costa ci portò sul 2-1, non fischiò neppure troppo Ghiggia che si fece espellere dall’arbitro, celebrò con una certa flemma la qualificazione dell’Irlanda del Nord per il campionato mondiale 1958 grazie al 2-1 conclusivo, non infierì se non con humour britannico sulla clamorosa eliminazione dell’Italia.
La quale Italia si consolò parzialmente con l’eliminazione «parallela» nel suo girone dell’Uruguay, l’unica altra squadra, insieme con quella azzurra, che poteva aggiudicarsi definitivamente la Coppa Rimet, avendo già conquistato due titoli mondiali.
Ci fu, da noi, un rigurgito nazionalistico, si cercò cioè di attribuire agli oriundi la colpa della nostra brutta figura, si disse che non avrebbero mai potuto lottare con sufficiente cuore: e intanto si cominciò a chiedere l’ingresso in Nazionale di Sivori, Angelillo e Maschio arrivati pochi mesi prima dall’Argentina…
In Svezia, nel 1958, il Brasile riuscì finalmente a diventare campione del mondo.
Vincitore del suo girone, dove stava con URSS, Inghilterra e Austria, il Brasile nei quarti di finale si liberò del Galles per 1-0, superò la Francia in semifinale per 5-2, e con lo stesso punteggio sconfisse in finale la Svezia, alla quale l’Italia aveva restituito un bel po’ dei giocatori prelevati dopo che la nazionale scandinava ci aveva umiliati nel 1950: Gustavsson, Hamrin, Gren, Liedholm, Skoglund…
A metà del torneo in terra svedese il Brasile presentò in attacco un ragazzo di diciotto anni, Edson Arantes Nascimiento, detto Pelé, con un soprannome onomatopeico, che stava a significare la sua felicità e la sua facilità nell’andare su e giù per il campo come una palla rimbalzante.
Aveva giocato qualche incontro, in quel Brasile, anche un certo Mazzola: al di là del soprannome, che ricordava la somiglianza fisica di questo ragazzo con Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto a Superga, c’era un cognome italiano, Altafini. José Altafini era stato acquistato, un mese prima che avesse inizio il campionato mondiale, dal Milan; sarebbe venuto in Italia, avrebbe giocato fino al 1976 per il Milan, per il Napoli, per la Juventus, costruendosi addosso una delle più colossali carriere calcistiche di tutti i tempi.
Nel ruolino di marcia del Brasile finalmente campione del mondo, un solo pareggio, lo 0-0 con l’Inghilterra. Molte emozioni, specialmente quando, nella finale, la Svezia aveva segnato con Liedholm il primo gol della partita. Molti pianti, colossali festeggiamenti a Rio, decisione immediata di fare eroe nazionale non solo Pelé, ma anche Garrincha, l’ala destra dalla finta elettrica, anche il grande centravanti opportunista Vavà, anche il grande «cervello» Didì, anche il grosso e grasso commissario tecnico, Vicente Feola, napoletano cresciuto in Brasile, artefice della prima autentica organizzazione del calcio brasiliano a livello internazionale. E anche Paulo Amaral, preparatore atletico, che sarebbe poi venuto come allenatore alla Juventus.
Il Brasile giocò con grande accortezza in difesa, specie grazie ai due anziani terzini Djalma Santos e Nilton Santos, negro il primo e bianco il secondo, e giocò con molta fantasia all attacco. Fra le riserve di quello straordinario Brasile, oltre ad Altafini, che fu in un certo senso «messo fuori» da Pelé, c’era anche Dino Sani, che sarebbe arrivato in Italia con la sua «pelata» e la sua classe, per insegnare sul campo, con partite favolose, il grande calcio agli italiani del Milan e specialmente a un giovanotto emergente che si chiamava Gianni Rivera.
Gli anni fra il 1958 e il 1962, fra l’edizione cioè della Coppa Rimet in Svezia e quella in Cile, furono i più pieni di cose, non necessariamente tutte positive, per il calcio italiano.
Abbiamo già detto dei grandi arrivi dall’Argentina. Sivori, Maschio e Angelillo, con l’aggiunta di Altafini e di Sormani, quest’ultimo brasiliano di autentiche, strette origini italiane, si inserirono nella Nazionale, se non altro con più classe rispetto ai loro predecessori (a proposito, per completare l’elenco degli argentini «usati» da noi negli anni precedenti, non bisogna dimenticare il nome del ^panciuto, pelato Ricagni).
Sono, questi, gli anni della confusione tecnica al vertice. La Nazionale passa al terzetto Mocchetti-Biancone-Viani, poi al terzetto Ferrari-Mocchetti-Biancone, poi a Viani da solo, quindi a Ferrari da solo, poi, proprio per il Cile, a Ferrari-Mazza-Spadaccini. La Federazione vede l’assalto dei grandi presidenti, cioè Angelo Moratti, Umberto Agnelli per la Juventus e Andrea Rizzoli per il Milan, ai poteri massimi del calcio, specialmente dopo che il Coni aveva imposto il 13 agosto di quel disgraziatissimo 1958, l’anno in cui la Coppa Rimet si era giocata senza di noi, Bruno Zauli, suo segretario generale, commissario del football in sfacelo.
C’erano scandali e corruzioni, il presidente del Coni, Onesti, definiva i mecenati del calcio italiano «ricchi scemi» ma alla fine questi mecenati vincevano battaglie e guerre, il giovane attivissimo Umberto Agnelli diventava presidente della Federazione, la Nazionale italiana riusciva a conquistare alcuni traguardi parziali importanti (intanto accedeva alla maglia azzurra anche l’argentino Lojacono), e nel 1960, ai Giochi Olimpici di Roma, una Nazionale formata tutta da giovani di squadre importanti arrivava
39 alla medaglia di bronzo, peraltro mettendo in mostra il miglior gioco di tutto il torneo. Il nome più importante di quella Nazionale era quello di Gianni Rivera.
Nello stesso 1960 arrivava in Italia Helenio Herrera, argentino-spagnolo-francese, a suggerire un nuovo corso negli allenamenti, nella psicologia del calciatore, negli stipendi. Lo aveva assunto l’Inter di Milano, strappandolo al Barcellona.
In sede internazionale, non potemmo… esimerci dalla qualificazione per la Coppa Rimet in Cile. Dovevamo giocare contro la Romania, unica nostra compagna nel gruppo eliminatorio, e la Romania diede forfait. Era in previsione successivamente un incontro di spareggio con la vincitrice di un girone misto, comprendente Cipro, Israele ed Etiopia. Venne opposta a noi la squadra di Israele. A Tel Aviv, nel match di andata, riuscimmo a chiudere il primo tempo in svantaggio per due gol, poi segnarono e pareggiarono l’argentino Lojacono e il brasiliano Altafini, e infine vincemmo 4-2 con due punizioni di Corso.
Nella partita di ritorno, a Torino, fu un 6-0; ben quattro gol di Sivori, argentino. E così andammo in Cile.
Stavolta si attraversò l’oceano in aereo, dopo una serie di partite di preparazione abbastanza interessanti. Capitammo nel girone della squadra di casa, il Cile, insieme con la Germania Ovest e con la Svizzera.
La spedizione nacque male per cause psicologiche. L’abbondante impiego nella nostra Nazionale di oriundi sudamericani ci procurò accoglienze ostili sin dall’arrivo a Santiago. In spagnolo, i tifosi cileni urlavano ai vari Sivori, Maschio, Altafini, che la loro vera maglia non era quella azzurra.
Riuscimmo, all’esordio, a pareggiare 0-0 con i tedeschi. Ma poi, contro il Cile, fu il patatrac. Articoli di giornalisti italiani che avevano «scoperto», per i loro lettori, le condizioni misere di esistenza di larga parte della popolazione cilena, rimbalzarono a Santiago, ci procurarono accuse gravi, scatenarono la folla locale contro l’Italia.
L’arbitro inglese Aston non fu all’altezza della partita che ci vide soccombere, alla fine di un’autentica rissa, per 2-0. Ferrini e David, i due azzurri più caldi, vennero espulsi, Maschio giocò in condizioni menomate per un pugno ricevuto da un cileno, Alta-fini fu coperto di sputi. Comunque, al di là delle circostanze ambientali, sbagliammo anche formazione: la triade tecnica era in realtà succuba di alcuni giornalisti e, a esempio, 1 estromissione di Sivori fu decisa da rappresentanti della carta stampata. Il torneo andò avanti senza di noi, eliminati nonostante un vittorioso 3-0 perfettamente inutile sulla Svizzera nell’ultimo incontro. Fu un torneo mediocre; neppure il Brasile col grande Pele riuscì a riscattarlo, anche perché lo stesso Pelé si infortunò molto presto. Lo sostituì, praticamente lanciandosi sulla ribalta internazionale (il che gip avrebbe puntualmente consentito di essere ingaggiato a peso d’oro in Italia), il negretto brasiliano Amarildo.
Nonostante lo stiramento di Pelé, nonostante l’età veneranda, canonica dei terzini Djalma e Nilton Santos (rispettivamente 37 e 36 anni), del centravanti Vavà (38!), il Brasile arrivò abbastanza facilmente alla finale. L’unica grossa fatica fu quella contro la Spagna, rimontata e sconfitta per 2-1. Allenatore della Spagna era Helenio Herrera, «imprestato» dall’Inter.
Il Brasile in finale giocò e vinse facilmente, per 3-1, contro la Cecoslovacchia, la stessa squadra che aveva incontrato nei gironi eliminatori, quando si era infortunato Pelé. Si disse che raramente la finale di un campionato mondiale era stata così moscia, e questo nonostante che il gol iniziale dei cecoslovacchi avesse creato un certo pathos nello stadio di Santiago. Il Cile arrivò addirittura al terzo posto, sconfiggendo la Jugoslavia. Forse, un premio eccessivo per il calcio di casa.
Edmondo Fabbri fu il commissario tecnico della Nazionale italiana per la Coppa del Mondo 1966, allorché i tifosi del calcio azzurro impararono due nuove geografie: la collocazione esatta in Inghilterra della cittadina di Middlesbrough, dove si consumò la nostra eliminazione, e la collocazione tecnico-agonistica della Corea del Nord, che ci eliminò nella scala dei valori mondiali.
Era un’Italia speciale quella che si presentava a quell’edizione del campionato del mondo. Fabbri, scelto per le sue qualità «ruspanti» messe in luce alla guida del Mantova, portato in pochi anni alla massima divisione e a un buon football, rinunciò a tutti i sudamericani, a eccezione del solo Sormani che, approdato in Italia dal Brasile quando ancora non era famoso (giocava nel Santos ed era chiuso nientepopodimenoché da Pelé), venne considerato di scuola, di creazione, di formazione, diciamo pure di cultura calcistica nostrana.
Gli anni dal 1962 al 1966 videro comunque, e grazie specialmente all’apporto dei calciatori stranieri, il Milan prima e poi, meglio ancora, l’Inter emergere nella grande Coppa europea dei Campioni. Praticamente, alla fine dell’era spagnola (Real Madrid, soprattutto, e Barcellona), in questa manifestazione arrivata presto a grandi fortune di pubblico, ci fu l’era italiana. L’Inter rifinì anche il successo di questo periodo con la conquista della Coppa Intercontinentale, una sorta di campionato mondiale per club. Il calcio italiano assunse, sulla ribalta internazionale, quotazioni superiori al suo stesso valore intrinseco.
L’andamento delle qualificazioni mondiali sembrò fatto apposta per illudersi. In un girone non facile non difficile, con Scozia, Polonia e Finlandia (si deve dire che gli scozzesi e i polacchi non avevano certo raggiunto i valori attuali), ci qualificammo matematicamente soltanto nell’ultimo incontro, ma non conoscemmo troppi affanni o passi falsi.
Con la Polonia fu un pareggio, con la Finlandia fu subito un vittorioso 6-1 ; poi, a Varsavia, pareggiammo 0-0 con la Polonia in un match che vide l’apertura ufficiale della polemica di Gianni Rivera contro Edmondo Fabbri, per l’impiego del libero Armando Picchi, dell’Inter, in un ruolo puramente difensivo, anche quando la pochezza degli avversari sembrava consigliarci esperimenti di attacco.
Praticamente, la relativa emarginazione di Rivera dalla squadra azzurra segnò il lancio definitivo di un altro grande giocatore di quel periodo, Sandro Mazzola. Vincemmo a Helsinki per 2-0, a Roma superammo la Polonia per 6-1, e in pratica ci giocammo la qualificazione con gli scozzesi: ci permettemmo di perdere a Glasgow per 1-0, ma vincemmo facilmente a Napoli per 3-0.
Nell’insieme, Edmondo Fabbri operò sino all’approdo in territorio inglese, dove il ritiro venne fissato a Durham, con relativa tranquillità.
Le partite di rodaggio prima del campionato del mondo, disputate in Italia, ci videro facili vincitori su Bulgaria (6-1), Austria (1-0), Argentina (3-0) e Messico (5-0). Tutti questi paesi, tranne l’Austria, dovevano giocare anch’essi nel Mondiale. In sostanza, arrivammo in Inghilterra con il ruolo, se non di favoriti, per lo meno di importantissimi attori della grande recita mondiale.
Il primo incontro, col Cile che ci aveva castigati quattro anni prima, fu un bel 2-0 per noi. La Nazionale, messa insieme a mosaico, sembrava aver trovato una sua dignità di gioco e di squadra. Fummo sconfitti dall’Unione Sovietica nel secondo incontro per 1-0, ma restava disponibile un incontro, sulla carta facilissimo, con la Corea del Nord, per andare avanti nel girone.
L’atmosfera nel ritiro azzurro era ancora abbastanza buona. Due ragazzini aggiunti alla comitiva, Gigi Riva e Gigi Meroni, giocatori promettenti, imparavano che l’ambiente azzurro non era così manicomiale come descritto dalla stampa negli anni precedenti. Meroni, per la verità, si era già «infilato» nella squadra azzurra, e avrebbe potuto giocare. Ma si preferì l’esperienza di elementi più anziani.
Tanta cautela nello stilare la formazione non si era accompagnata però a una pur elementare cautela nei riguardi degli avver-sari nordcoreani, che non erano stati neppure visionati da osservatori titolati, delegati da Edmondo Fabbri, L’incontro di Middlesbrough addì 19 luglio 1966, è ancora ricordato come il peggior momento di tutta la storia del calcio italiano. Fabbri lasciò a riposo Burgnich, Rosato, Salvadore, pensò che un gruppetto di azzurri esperti fosse sufficiente per i coreani. Dominammo per la prima mezz’ora, senza mai concretizzare, fallendo con Perani tre palle-gol. Al 33’ perdemmo Bulgarelli che, sceso in campo già in precarie condizioni fisiche, si infortunò in un contrasto a centrocampo, con un’azione fallosa da parte sua. Al 42’ il meccanico dentista nordcoreano Pak Doo Ik, con un tiro da lontano, infilò la porta azzurra. Restavano 48 minuti per recuperare, e non recuperammo. L’intero mondo del calcio rise di noi, e per fortuna qualche giorno dopo la Corea del Nord, qualificatasi al nostro posto, insieme con 1 Unione Sovietica, riuscì a portarsi in vantaggio per 3-0, prima di soccombere per 5-3, contro il quotatissimo Portogallo di allora. Perlomeno, le venne riconosciuta una validità autentica, non relativa alla nostra pochezza. Ma ormai era tardi anche per un recupero morale. La squadra azzurra era già rientrata in Italia. All aeroporto di Genova pomodori marci avevano accolto Fabbri e i suoi. Il Mondiale 1966 andò avanti senza di noi.
Eliminata l’Italia, il secondo fatto, diciamo così, scandalistico di quella edizione mondiale fu l’eliminazione del Brasile, con un Pelé brutalizzato dai difensori bulgari e portoghesi.
Qualcuno parlò di fine di un’era del calcio, appunto il calcio brasiliano artistico, qualcun altro si limitò a dire che si trattava di un declino momentaneo, di una crisi assolutamente contingente, evidenziata poi dagli infortuni a Pelé, scarsamente protetto dagli arbitri.
Gli arbitri per la verità furono i protagonisti di quel campionato mondiale. Un inglese fece vincere, così si disse, la Germania Ovest contro l’Uruguay, nei quarti di finale; e il punteggio di 4-0 per i tedeschi non consegna esattamente agli archivi quella che fu la grande sfortuna uruguaiana. Sempre un arbitro, tedesco questa volta, propiziò 1’1-0 dell’Inghilterra Sull’Argentina, in una delle più turbolenti partite di tutta la storia togata del calcio mondiale, con espulsioni e scazzottature. In semifinale l’Inghilterra si liberò del Portogallo, la Germania si liberò dell’Unione Sovietica, che aveva eliminato l’Ungheria. (Quanto al Portogallo, si era fermato nei quarti a spese della Corea del Nord: identico il punteggio di 2-1.)
Le squadre inglese e tedesca, abbastanza complici fino a quel momento, divennero ferocemente nemiche in occasione della finale di Wembley. L’Inghilterra giocò la finale nello stesso stadio in cui aveva disputato sin lì tutte le partite del campionato del mondo. La partita andò avanti fino ai tempi supplementari, dopo che i primi 90’ si erano chiusi sul 2-2, e fu deciso, nella prima delle due frazioni «extra», da un gol molto discusso di Hurst: la palla scagliata dall’inglese batté sulla faccia inferiore della traversa e rimbalzò in campo, non si sa ancora bene adesso se al di qua o al di là della linea.
Su segnalazione di un guardalinee sovietico, l’arbitro svizzero Dienst concesse la rete. Hurst segnò anche nel secondo tempo supplementare, e fu 4-2 per l’Inghilterra.
La Coppa Rimet edizione 1966 è ricordata come quella del trionfo del fattore campo. Al terzo posto finì il Portogallo, vincitore, nella partita di consolazione, dell’Unione Sovietica. L’uomo dei mondiali, con Pelé coperto di lividi, fu un altro negro, Eusebio del Mozambico, attaccante della nazionale portoghese. I non-uomini del mondiale furono gli italiani.
Per il nostro calcio, che nell’ultimo quadriennio aveva conosciuto importanti successi, la batosta fu tremenda. Non insegnò nulla, ma distrusse molto, se non tutto. Il primo gennaio 1965 erano state chiuse in Italia le importazioni degli stranieri. E non solo di loro, ma anche degli italiani o oriundi italiani tesserati presso federazioni estere. Il provvedimento, a scopo di moralizzazione e anche di rilancio del nostro vivaio, non riuscì a impedire al Milan di diventare campione d’Europa e poi campione del mondo di club, usando anche giocatori stranieri che erano già in Italia precedentemente al divieto.
Per la Nazionale, tolta a Fabbri dopo il disastro contro la Corea del Nord, si cercò di fare più che altro dell’ecologia spicciola, e neppure immediatamente. Infatti inizialmente si cercò l’esotico, diciamo pure l’artificiale, affidandola a Helenio Herrera in coabitazione con Ferruccio Valcareggi.
Ma dopo quattro mesi lo stesso Valcareggi, che era stato aiutante di Fabbri nella spedizione inglese, ebbe la responsabilità piena. Si andava verso la Coppa Rimet da disputare in Messico, nel 1970, e si cominciò per tempo a parlare di tutti i problemi connessi all’altitudine dei pianori messicani.
Una storia di doping, venuta fuori nella scia lunga delle polemiche per il fattaccio nordcoreano, non riuscì a turbare troppo l’ambiente del calcio italiano.
Due anni dopo il disastro di Middlesbrough, diventammo campioni europei in circostanze abbastanza complicate, ma tutto sommato con un certo merito. L’uomo di quegli anni fu Gigi Riva, ala sinistra e mancina del Cagliari, alle cui bordate furono legatissime, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, le sorti della nostra Nazionale.
Quanto accadde nella Coppa Rimet 1970, e nel quadriennio precedente, ha già i contorni della storia e conserva la vivezza della cronaca. Un incontro, quello disputato fra Italia e Germania, disputato il 17 giugno nello stadio Azteca di Città del Messico, ha avuto un’eco specialissima, che è andata ben al di là del valore
44 statistico dell’incontro stesso. L’Italia ha vinto per 4-3 dopo i tempi supplementari: era la semifinale del campionato del mondo di calcio, è stata la partita che ha ribaltato talune credenze relative alla squadra azzurra, al calciatore italiano e addirittura all’italiano tout-court. Il mondo si è sorpreso nel vederci agonisti, combattivi, „ tenaci, volenterosi, disperati di una disperazione lucida. I primi sorpresi, tuttavia, siamo stati noi stessi. Probabilmente nessun incontro nella storia del nostro calcio, nessun avvenimento nella storia del nostro sport ha inciso così profondamente i pensieri, le credenze nazionali.
Se si vuole trovare a tutti i costi un contraltare, o un paragone, a quanto accaduto quel pomeriggio a Città del Messico, e quella notte (per vie dei fusi orari) in Italia, non al calcio bisogna fare ricorso, nonostante due vittorie in due finalissime del campionato del mondo, non all’atletica nonostante il Livio Berruti vittorioso a Roma I960, non al pugilato nonostante i Camera e i Benvenuti, ma soltanto al ciclismo, grazie ai Bartali e ai Coppi: e comunque la mobilitazione notturna, in ore decisamente scomode, dell’Italia sportiva non trova riscontri neppure nella mobilitazione diurna per i grandi successi dei nostri pedalatori ai Giri di Francia e d’Italia.
Neppure nel 1968, due anni prima della Coppa Rimet, con la conquista del campionato europeo, si era pallidamente intuito quale poteva essere la presa, l’impatto del football nei riguardi della nostra pubblica opinione e anche della nostra piazza, scatenata nell’occasione dei grossi esiti sportivi. Eravamo diventati campioni d’Europa, vincendo il trofeo intitolato anche questa volta a un francese, Henry Delaunay, proprio nell’edizione organizzata in Italia. Questa organizzazione fu il primo grossissimo successo di prestigio di Artemio Franchi, dal 1967 presidente della nostra Federazione. Il nostro football scalcinatissimo, umiliatissimo due anni prima dalla Corea del Nord, riuscì a mettere in piedi una manifestazione dignitosa.
Per la verità la dignità sembrava essere andata a farsi friggere in occasione del primo match di finale contro la Jugoslavia. Avevamo chiuso sull’1-1, riuscendo così a guadagnare diritto a una seconda prova, dopo che la Jugoslavia aveva dominato per larga parte dell’incontro, segnando al 39’ con Dzajic, colpendo una traversa, insomma facendosi «morire» di paure assortite.
Si deve dire che alla finalissima con la Jugoslavia eravamo arrivati dopo uno 0-0 con l’Unione Sovietica a Napoli, 0-0 confermato dai tempi supplementari e «incrinato» soltanto dalla monetina, che ci aveva dato il diritto di giocare la finalissima contro gli slavi, vincitori intanto degli inglesi per 1-0.
La prima partita di finale fu conclusa sull’1-1 da undici italiani piu un elvetico, l’arbitro Dienst, che ci permise di portare in porto il pareggio (Domenghini pareggiò Dzajic) con varie decisioni a nostro favore. Due giorni dopo, la nostra squadra, più ricca di uomini freschi, vinse chiaramente per 2-0, con gol di Gigi Riva e di Pietro Anastasi, su una Jugoslavia abbastanza tramortita dalla stanchezza, abbastanza handicappata dalla carenza di uomini di riserva e decisamente stressata dall umiliazione psichica subita due giorni prima.
Non ci furono comunque, in giro, troppe riserve sulla nostra vittoria. Di un successo, o quanto meno di una riaffermazione italiana, sembrava avere bisogno tutto il football mondiale, che non poteva rinunciare troppo facilmente alla caduta di certi suoi valori.
In quel quadriennio che per noi andò dalla Corea del Nord alla esibizione felice sull’altopiano messicano, il calcio italiano conobbe anche, novità statistica, due smistamenti dello scudetto fuori dall’area torinese-milanese. Nel 1968-69 vinse, davanti al Cagliari, la Fiorentina, che era la prima compagine nella storia del grosso calcio italiano capace di conquistare il massimo titolo senza avere una formazione con schieramento a maggioranza di giocatori lombardo-veneti. La stagione successiva, quella 1969-70, il trionfo toccò addirittura al Cagliari, squadra che da pochi anni aveva lasciato le divisioni inferiori. Il Cagliari aveva all’ala sinistra quel Gigi Riva che stava, intanto, decidendo le fortune della squadra azzurra. Un particolare, che ovviamente allora non venne colto nella sua portata storica ma che è giusto segnalare adesso, merita di essere sottolineato: 1970, anno del campionato del mondo, anno di una squadra outsider, il Cagliari, campione d’Italia. Quattro anni dopo, 1974, il titolo sarebbe andato a un’altra outsider, la Lazio.
Nel 1970 si parlò addirittura di miracolo di Riva; nel 1974 qualcuno avrebbe cominciato a dire di stagione amorfa, rilassata delle grandi squadre nell’anno del campionato del mondo, quasi che i loro giocatori pensassero soprattutto alla maglia azzurra, alla custodia delle gambe preziose, in vista dell’appuntamento internazionale. Ovviamente ci vorrà una ulteriore stratificazione di dati per una argomentazione seria su tutto ciò. Ma resta interessantissimo questo fatto del Cagliari e della Lazio campioni d’Italia proprio in anni in cui le squadre che erano il serbatoio tradizionale della Nazionale azzurra vedevano i loro giocatori impegnati in una attenta conservazione del patrimonio personale di muscoli e ossa.
La Nazionale di Ferruccio Valcareggi si qualificò con una relativa giusta, onesta difficoltà nel proprio girone, contro il Galles e la Germania Est. Riuscimmo a incontrare i nostri avversari prima in trasferta, riservandoci il fattore campo per i match conclusivi. In ogni caso un gol di Riva ci servì per battere il Galles a domicilio e per pareggiare (2-2) a Berlino Est. In Italia tre gol di Riva e uno di Mazzola siglarono il 4-1 sul Galles, mentre un gol di Mazzola uno di Domenghini e uno (ovviamente) di Riva significarono il 3-0 sulla Germania Est.
Tirava un vento anche fortunato, intorno alla nostra squadra Il sorteggio per il Mondiale in Messico ci assegnò Uruguay, Svezia e Israele, avversari non trascendentali: la Nazionale uruguaiana era sì magnanima di lombi, era sì, come Italia e Brasile, laureata due volte campione del mondo e quindi nella possibilità teorica di aggiudicarsi la Coppa Rimet, ma cominciava a conoscere, nelle fibre del suo football, il dramma dell’intero paese, che da «Svizzera del Sudamerica» stava precipitando in una situazione balcanica, per ragioni eminentemente politiche.
Puebla e Toluca, rispettivamente 2.155 e 2.640 metri sul livello del mare, furono le sedi del raggruppamento azzurro (ricordiamo che Città del Messico era-c a quota 2.280). Riuscimmo a vincere il nostro girone segnando un solo gol, quello di Domenghini per 1’1-0 nostro contro la Svezia. Uno 0-0 saggio contro gli uruguaiani, uno 0-0 umiliante contro Israele furono i punteggi (si fa per dire) che completarono il nostro lasciapassare.
Nei quarti di finale ci toccò, per il match a eliminazione diretta, il Messico, e lo stadio assegnatoci fu quello di Toluca, in altissima quota. Segnarono subito i messicani, rispondemmo con Domenghini, mettemmo al sicuro il punteggio con due reti di Riva e una di Rivera. A proposito di Rivera, quella fu l’occasione in cui ebbe inizio la famosa staffetta fra lui e Mazzola, visto che il commissario tecnico, Valcareggi, non se la sentiva di scegliere decisamente uno dei due, a scapito dell’altro, visto che la maggioranza dell’Italia calciofila e calciomane optava per l’impossibilità di schierare insieme i due talenti, così vividi e così spiccati da risultare anche ovattanti uno nei confronti dell’altro.
E così si arrivò alla semifinale con la Germania Ovest, che si era liberata dell’Inghilterra, che aveva vinto quattro partite su quattro, che sin lì aveva messo a segno tredici reti, otto delle quali grazie a Gerd Müller, centravanti dalle gambe corte, dal tronco lungo, piuttosto sgraziato, grossissimo confezionatore di gol.
Nella parte iniziale della partita, il centravanti Boninsegna, che era andato in Messico sostituendo all’ultimo minuto Anastasi, vittima di un abbastanza misterioso infortunio la sera prima della partenza della squadra azzurra da Roma, segnò su servizio di Riva. Per tutta la partita i tedeschi si scaraventarono contro la nostra rete, presero una traversa, costrinsero i nostri difensori a respinte a portiere battuto e costrinsero il portiere Albertosi a sciorinare una serie di prodezze. L’arbitro messicano Yamasaki, di origine giapponese, concesse due minuti di recupero ai germanici, proprio per la tattica ostruzionistica degli italiani. Beckenbauer, il migliore dei tedeschi, almeno sul piano della classe, giocava con un braccio al collo, per una lussazione. Tutto sembrava deciso pro nobis, quando Schnellinger, difensore dei tedeschi che ormai da quasi un decennio militava nel campionato italiano, dove era diventato uno dei punti di forza del Milan, entrò sul pallone in scivolata e riuscì a pareggiare.
Si dovette ricorrere ai tempi supplementari, di quindici minuti l’uno. Tutto faceva pensare che gli italiani non avessero nelle gambe altri trenta minuti di grosso football. In Italia e in Germania cinquanta milioni di persone restarono sveglie davanti ai televisori. Il gioco dei fusi orari faceva sì che la partita «trascinasse» ormai i tifosi, in Europa, verso le prime luci dell’alba. I tedeschi segnarono quasi subito per un mezzo autogol dell’italiano Poletti, subentrato a Rosato, ci portò sul 2-2 Burgnich, un difensore, con un gol molto simile a quello segnato da Schnellinger. Riva ci diede il 3-2, Müller sancì il 3-3 di testa ma, un minuto dopo, Rivera, su un passaggio di Boninsegna, sbagliando probabilmente il tocco, mise nella porta tedesca un pallone imprendibile: 4-3 per noi, più niente da fare per i tedeschi, la conclusione, il delirio anche del pubblico messicano, se non altro per il supplemento straordinario di spettacolo offerto, una targa murata nello stadio Azteca, ai tedeschi una coppa speciale degli organizzatori messicani (la scritta è quasi ironica: vencido y vencedor, siempre con honor), e per noi l’accesso alla finale, il 21 giugno.
Ci aspettava il Brasile, che era andato avanti dopo questi risultati: 4-1 alla Cecoslovacchia, 1-0 all’Inghilterra, 3-2 alla Romania,. 4-2 al Perù e 3-1 all’Uruguay. Dopo diciotto minuti i brasiliani erano già in vantaggio, con uno stupendo stacco di testa di Pelé, che era salito nel blu a colpire la palla, nonostante l’opposizione di Burgnich. Verso la fine del primo tempo rispondemmo con Boninsegna, che pareggiò sfruttando un equivoco dei difensori brasiliani. Nella ripresa crollammo; Gerson da lontano, Jairzinho e Carlos Alberto da vicino firmarono il 4-1 per il Brasile. A sei minuti dalla fine facemmo rifunzionare la staffetta. Rivera, che ci aveva miracolati contro la Germania, subentrò a Mazzola, ma non potè ovviamente fare il miracolo anche questa volta. Sui suoi ultimi sei minuti si discusse a lungo, in Italia.
Secondi nel Mondiale con un risultato che nessuno aveva osato prevedere alla vigilia, ricchi soprattutto delle «stimmate» per il vittorioso incontro sulla Germania, gli azzurri rientrarono in Italia. All’aeroporto di Roma ci fu molta confusione fra gli «evviva» e gli «abbasso». Mentre alcuni issavano in trionfo i giocatori, e cercavano di «aggredirli» con tutto il loro affetto, vennero sparati addirittura colpi di pistola contro la carlinga dell’aereo. Gianni Rivera divenne il pretesto per i contestatori a tutti i costi, divenne il simbolo di quelli-che-non-sono-mai-contenti. Riuscimmo a non goderci pienamente il secondo posto, conquistato appena quattro anni dopo l’umiliazione della Corea, che ci aveva sbattuti all’ultimissimo posto nel mondo. Tuttavia, in sede di quotazione esterna il calcio azzurro riprese valore e vigore.
In sede di revisione critica, si disse che in quel Mondiale eravamo stati fortunati, che l’incidente di Niccolai, stopper del Cagliari, uscito dopo mezz’ora di gioco nel primo incontro, quello dell’1-0 con la Svezia, aveva permesso il lancio grosso di Rosato elemento chiave della difesa azzurra. Si disse pure che l’infortunio patito a Roma da Anastasi aveva permesso il lancio involontario di Boninsegna, responsabilizzato ed efficientissimo. Si discusse molto su una malattia diplomatica di Rivera, forse ingigantita dal clan azzurro, si trascinarono discussioni sulla contestazione che lo stesso Rivera aveva mandato avanti, in Messico, nei riguardi del responsabile del settore tecnico federale, Mandelli. Si recriminò sul rendimento non eccelso di Gigi Riva. Insomma, si fece di tutto per cavillare sul secondo posto, per rimpiangere un assolutamente ipotetico primo posto, per sporcare all’italiana il molto di buono che era stato fatto.
Le stesse manifestazioni di giubilo in Italia, con milioni di persone nelle strade, a suonare il clacson per svegliare tutti quelli che per caso erano riusciti a non sapere che l’Italia in semifinale aveva sconfitto la Germania, vennero presentate come malcostume nazionale. In sé, era pure vero. Resta però il fatto che si perdette l’occasione, abbastanza rara nella storia del nostro calcio, non solo di godere di quello che era stato dopo tutto un successo (in quell’occasione fu coniata la dizione di «vicecampioni del mondo»), ma anche di sfruttare gli insegnamenti per fare ancora meglio la volta
I teorici del difensivismo a ogni costo dissero che, se avessimo schierato nella finale contro il Brasile una Nazionale insieme più fresca e più prudente, rinunciando ai sogni di vittoria per coltivare sogni di pareggio, forse avremmo fatto registrare la sorpresissima. In realtà, lo stacco di classe fra Brasile e Italia nella finalissima fu perentorio, perlomeno come lo stacco aereo di Pelé nei riguardi di Burgnich, in occasione del primo gol.
Da allora, ufficialmente, per il football italiano nacquero i cosiddetti «messicani», cioè gli atleti che avevano raggiunto quel risultato tutto sommato valido, ancorché recepito dall’opinione pubblica italiana più come grande promessa mancata che come grossa affermazione raggiunta. Gli atleti «messicani» condizionarono, perlomeno in maglia azzurra, larga parte del football nostro internazionale, nei successivi quattro anni. Eliminati nelle qualificazioni
49 di Coppa Europa, i «messicani» conservarono tuttavia dignità e validità, specialmente grazie a tre sensazionali partite che statisticamente segnarono a fondo il nostro calcio.
Il 9 giugno 1973 l’Italia sconfisse a Roma il Brasile campione del mondo. Con una certa dignità rinunciammo a presentare quel match come incontro di rivincita della finalissima dello stadio Azteca, tre anni prima. Tuttavia, la valutazione del nostro successo fu notevole. Il 14 giugno di quello stesso 1973, a Torino, celebrando i settantacinque anni della Federazione Italiana Gioco Calcio, gli azzurri riuscirono finalmente, dopo quattro sconfitte e quattro pareggi, a battere l’Inghilterra. Il match non ebbe nulla di amichevole, l’Inghilterra si disse anche vittima di una congiura arbitrale. In ogni caso vincemmo, e ribadimmo la legittimità di quel successo il novembre di quello stesso 1973, il 14 novembre, vincendo a Wembley per 1-0.
Nello stesso anno, insomma, ci liberammo del condizionamento statistico relativo al «nessuna-vittoria-finora» contro l’Inghilterra e addirittura distruggemmo anche il mito a noi ostile dello stadio massimo del calcio mondiale, Wembley appunto: dopo il 2-0 a Torino, ci fu l’1 a 0 a Londra, con un certo diritto all’illusione per il campionato del mondo 1974, che doveva svolgersi in Germania.
A quel campionato del mondo, o per meglio dire alla sua fase finale, accedemmo eliminando Svizzera, Turchia e Lussemburgo, praticamente senza nessuna difficoltà, nonostante il lusso sublime di un pareggio interno, a Napoli, contro i turchi. Il gruppo che ci venne assegnato in Germania, quello di Stoccarda e di Monaco, contro Argentina, Polonia e Haiti, fu considerato tutto sommato abbastanza «potabile». La squadra era sempre affidata a Ferruccio Valcareggi, i messicani erano abbondantemente presenti, in Germania avevamo in porta Dino Zoff, che da 1097 minuti non prendeva un gol in Nazionale. Persino grandi settimanali statunitensi mettevano in copertina il magico portiere italiano. Eravamo decisamente tra i favoriti, e l’ambiente caldo della zona intorno a Stoccarda, farcita di lavoratori italiani, ci dava garanzie di un grosso appoggio.
Il primo match fu quello contro Haiti, a Monaco. Era il 15 giugno di quel 1974 e Zoff, dopo 1143 minuti d’imbattibilità, capitolò: 1’ della ripresa, rete di Sanon. Da lì cominciò il nostro drammatico «inseguimento», da lì ebbe origine un faticatissimo 3-1 (rete di Rivera, autorete di Auguste, rete di Anastasi), che doveva avere poi il suo peso nel computo finale dei gol fatti e presi. Stavamo infatti con Argentina e Polonia, oltre che con Haiti.
Con l’Argentina fu un pareggio, 1-1, grazie a un’autorete di Perfumo: e cominciammo a mostrare paurosamente i nostri limiti.
L’alchimia dei punteggi ci garantiva comunque il passaggio ai quarti di finale, riservato alle due prime squadre del girone, in caso di pareggio con la Polonia. E siccome lo stesso pareggio poteva servire alla Polonia, italianissimamente si pensò a un automatico accordo. In realtà, invece, i polacchi ci maltrattarono, si portarono sul 2-0 grazie anche a un arbitraggio a noi sfavorevole, contennero facilmente, negli ultimi cinque minuti, il nostro arrembaggio dopo il gol del 2-1 segnato da Capello. Fummo eliminati anche per la differenza reti, perché l’Argentina sconfisse Haiti per 4-1, meglio di noi.
Per la partita decisiva, quella appunto contro la Polonia, Valcareggi aveva preso la decisione di estromettere sia Riva, fuori condizione fisica, dopo avere dato, negli anni precedenti, due gambe (due fratture) alla causa azzurra, sia Rivera, letteralmente stremato per ragioni psicoanagrafiche. Già c’era stata, negli incontri precedenti, la grana di Chinaglia, che nell’incontro con Haiti era stato sostituito da Anastasi ed era uscito dal campo facendo gestacci verso la panchina italiana. Chinaglia era stato psicologicamente recuperato (così almeno si diceva) alla fine di lunghi patteggiamenti, di un umiliante lavoro diplomatico.
La partita con la Polonia fu quella dell’autentica nostra umiliazione. Nell’intervallo pare si sia giocata anche la carta suprema, quella del discorso chiaro, a gesti o a cifre, con i polacchi, come noi interessati a un pareggio. Si pensò che garantendo loro la nostra non aggressività, esentandoli dal rischio della sorpresa, saremmo riusciti a farci capire. Non fu così, venimmo eliminati. Il campionato mondiale andò comunque avanti benissimo anche senza di noi. La Polonia che ci aveva fatto fuori proseguì il suo cammino, nei quarti che in pratica secondo la nuova formula inglobavano anche le semifinali, perse di misura contro la Germania Ovest, finendo comunque seconda nel girone, davanti a Svezia e Jugoslavia. Intanto dall’altra parte del tabellone l’Olanda si qualificava per la finalissima davanti al Brasile, alla Germania Est e all’Argentina. Si allentava nel torneo la tensione politica, si rilassava la polizia. La fase finale non era più «sincopata» dai provvedimenti speciali di controllo, di sorveglianza, che avevano soprattutto riguardato le partite, a Berlino, delle due Germanie contro il Cile, e delle due Germanie fra di loro.
In finalissima, dopo che la Polonia si era aggiudicata il terzo posto contro il Brasile, battuto dall’Olanda in una partita fra le più violente, e intanto onestamente virili, della storia del football, arrivavano Germania Ovest e appunto Olanda.
I tedeschi occidentali avevano perduto soltanto contro i tedeschi orientali, e quella di Berlino era ormai stata classificata e fagocitata come una partita «politica», in cui si era giocato a molti giochi, il calcio neppure al primo posto fra questi. L’Olanda aveva patito un solo pareggio contro la Svezia. Doveva vincere in finale l’Olanda, suo era il miglior gioco, atletico e divertente, tutto il campo per tutti i giocatori, ma football nuovo, con grande dispendio energetico e grande resa pratica e fantastica insieme.
L’Olanda cominciò segnando: fallo su Cruyff, rigore, gol. Poi si organizzò la Germania di Beckenbauer, un altro rigore le diede il pareggio, un gol di Miller, rapinatore di classe, le diede là vittoria. I difensivisti celebrarono il trionfo delle loro idee: e cioè la Germania avrebbe esaltato il loro verbo, giocando contratta, lasciando l’iniziativa agli olandesi. In realtà gli olandesi l’iniziativa se l’erano presa, si erano buttati avanti bene, avevano avuto cedimenti assoluti del fiato e relativi di alcuni uomini fra i quali lo stesso Cruyff, troppo responsabilizzato dall’essere stato sin lì il fenomeno del Mondiale.
La finalissima fu semplicemente uno scontro di atleti, i tedeschi furono più atleti, e dimostrarono di avere assimilato in pochi giorni la regola olandese del tutto football a tutto campo. In pratica, gli artisti olandesi insegnarono agli artigiani tedeschi il football della feroce applicazione: e gli allievi, applicando gli insegnamenti alla perfezione, e godendo di migliore salute, vinsero il confronto diretto con i maestri. Esplose in tutto il mondo la «fregola» del gioco all’olandese, del tuttocampo, si cominciò la costruzione di atleti senza ruolo, però validi per tutti i ruoli. Anche l’Italia, dove tutto sommato l’eliminazione aveva fatto più dolore che scandalo (un progresso), si adeguò, o cercò di adeguarsi.
In quella estate del 1974, molti allenatori di club cambiarono i moduli di allenamento. Il sudore divenne o ridivenne sacro. La preferenza venne data ai cursori, agli atleti. Con una opportuna cautela, spartimmo anche noi la moda del gioco all’olandese. In quello stesso 1974 proprio l’Olanda, eliminandoci dal campionato europeo, ci disse che dovevamo imitarla. Non esagerammo nell’imitazione per pure carenze fisiche. Intanto decadeva l’Olanda, anche perché il calcio è questione di uomini, di singolo, per un buon x per 100, e i bipedi olandesi, uno per uno, si fecero (soldi? sazietà?) diversi da quelli che erano. Ma veniamo alla nostra storia.
L’eliminazione dell’Italia costò il posto a Valcareggi, secondo copione, secondo prassi. Lo sostituì Fulvio Bernardini, un vecchio signore, ex giocatore di grido, splendido personaggio di cappa e spada, ancorato però a un football antico. A fianco di Bernardini, si stagliò sempre meglio Enzo Bearzot, già calciatore del Torino, dell’Inter e del Catania, uomo «loico», frequentatore di tanti stadi all’estero per vedere, per sapere, per conoscere.
Ben presto Bearzot rimase responsabile unico, impegnato nel difficilissimo compito di qualificare per il 1978 l’Italia nonostante che la fase eliminatoria ci avesse assegnato, insieme con la Finlandia e con il Lussemburgo, nientepopodimenoché l’Inghilterra
Agli inizi della sua difficile gestione, Bearzot fece chiaramente intendere che si sarebbe appoggiato al blocco torinese: Juventus e Torino, e Juventus più che Torino, vista la dominazione bianconera, ormai ricorrente, più o meno anno dopo anno, nel calcio italiano. Un 4-1 nell’esordio contro il modestissimo Lussemburgo sembrò brutta cosa, visto che l’alchimia dei gol pareva dover essere quella che avrebbe condizionato la qualificazione. A Roma l’Inghilterra si presentò però in formazione-suicida, senza un’ideologia di gioco, e l’Italia, con gol di Antognoni e Bettega, la sconfisse 2-0. Su quella vittoria speculammo (nessuna vergogna nel dire ciò) molto accortamente: 3-0 a Helsinki sulla Finlandia, che sullo stesso terreno aveva ceduto agli inglesi per 4-1, 6-1 a Torino sempre sulla Finlandia, e finalmente la visita all’Inghilterra discretamente rilassati, specialmente dopo che gli inglesi non erano andati al di là del 2-0 sui lussemburghesi.
A Wembley, giocando malissimo, perdemmo benissimo ai fini della matematica del girone: 2-0. Ci presentammo all’ultima partita, quella con il Lussemburgo, con l’obbligo soltanto di vincere, anche soltanto per 1-0. Fu un 3-0 tutt’altro che esaltante, ma fu la qualificazione per la Coppa del Mondo 1978, in programma dal 1 al 25 giugno in Argentina.
Il 14 gennaio 1978, a Buenos Aires, l’Italia è stata sorteggiata nel girone dell’Argentina padrona di casa, dell’Ungheria e della Francia. Alla vigilia, il complesso patteggiamento per la designazione delle teste di serie aveva, per la prima volta nella storia del campionato del mondo, portato gli organizzatori a designare cinque squadre «primarie», anziché quattro. Due di queste nello stesso raggruppamento: Argentina e Italia. Con l’Italia dislocata a Mar del Piata, mentre l’Argentina dovrà giocare tutti i suoi incontri a Buenos Aires.
Il motivo? Turistico, essendo Mar del Piata località in grado di recepire l’intenso movimento di italiani d’Argentina, italiani del Sudamerica, italiani d’Italia, che si suppongono appiccicati alla squadra azzurra. In realtà la complessa alchimia, che avrebbe favorito abbastanza sfacciatamente l’Argentina e l’Italia se nel loro girone fossero state sorteggiate, secondo le alternative, la Svezia al posto dell’Ungheria, la Tunisia o l’Iran o l’Austria al posto della Francia, si rivelò una beffa: Ricardo Teixeira Havelange, tre anni, nipote del presidente della FIFA, ha assegnato all’Argentina e all’Italia l’Ungheria, che sulla carta è molto più «dura» della Svezia, e la Francia, che sulla carta è molto più dura dell Austria, per non dire addirittura della Tunisia o dell’Iran. Il girone di Italia e di Argentina è il più difficile. Qualcuno dice che sarà temprante, e c’è chi ricorda che l’Italia, tutte le volte che è stata posta di fronte a un grosso muro, se l’è cavata bene, mentre è andata malissimo contro la Svizzera, il Cile, la Corea del Nord, Haiti… Ma siamo ormai sul terreno delle previsioni, dove ognuno è re.
Piuttosto, è giusto, diremmo anzi che è doveroso, assumendo tutti i rischi che ciò comporta, andare a parlare del calcio che il mondo aspetta per l’undicesima edizione del campionato del mondo stesso.
Sedici squadre, che, come abbiamo detto all’inizio di questo discorso, non sono assolutamente in grado di rappresentare esaurientemente il mondo da un punto di vista geopolitico, cercano di rappresentare alcune scuole calcistiche mondiali, e devono far fronte alle promesse per lo meno di emozioni.
Le squadre sono state suddivise in quattro gruppi. Le prime due di ogni gruppo, dopo una serie di incontri secondo la formula del girone all’italiana (ognuno incontra tutti gli altri una volta sola) si qualificano per la fase successiva, i quarti di finale; Vi rimandiamo alla lettura del tabellone, che ipotizza anche gli incontri successivi, sia pure con i nomi delle squadre sostituiti da sigle. I quarti di finale si svolgono anch’essi secondo il girone all’italiana, e l’eliminatoria diretta è riservata, come già avvenne quattro anni fa, soltanto alle semifinali, che laureano le due squadre che si batteranno per il titolo e quelle che si batteranno per la non mai sufficientemente nobilitata finale per il terzo e quarto posto.
La geopolitica, per non dire addirittura la politica del football, ha fatto sì che sulla carta due gironi risultino spaventosamente facili, due spaventosamente difficili. Argentina, Italia, Ungheria e Francia, secondo un ordine che assolutamente non è alfabetico, ma che potrebbe essere quello della classifica finale, si scanneranno nel primo girone. Nel secondo girone, Germania Ovest campione del mondo e Polonia dovrebbe avere vita facilissima contro Tunisia e Messico. Nel terzo.girone, discrete complicazioni per il Brasile, opposto a Svezia, Spagna e Austria. Nel quarto girone, tutto appare facile per Olanda e Scozia contro Perù e Iran.
Certi pronostici sembrano troppo difficili, certi altri troppo facili. Sicuramente qualcosa andrà in maniera completamente opposta alle previsioni. Non si può tuttavia prevedere che l’Italia possa godere di una facilità di cammino.
Molto si aspetta da questa edizione del calcio mondiale, che si svolge in Argentina, uno dei luoghi deputati allo sciorinio del miglior football. Si dice che il verbo atletico, «olandese» per quella che fu la sua esemplificazione massima, ancorché non premiata dal successo finale, nell’ultima Coppa del Mondo, dovrebbe ricevere un certo colpo. In altre parole, dovrebbe tornare a imporsi un football più giocato, meglio meditato, più artistico. Un football in un certo senso latinizzato, anche se alla sudamericana più che all’europea. Si parla di Olanda in decadenza, se non altro per il mancato apporto di Cruyff, che per ragioni politiche e insieme anagrafiche ha preferito rinunciare al Mondiale, dove sarebbe stato il bersaglio insieme di eventuali terroristi e di eventuali difensori killers. Si parla di una Germania Ovest in decadenza, perlomeno quanto a tasso di classe, ancorché continui a essere una strepitosa macchina da gioco: dovrebbero però mancarle la classicità di Beckenbauer, le invenzioni di Müller, gli estri di Netzer, di Overath e di Breitner. È in decadenza la Polonia; sono emergenti o riemergenti, ma forse non abbastanza per le esigenze di un campionato del mondo, Ungheria, Francia e Austria; la Spagna assomiglia un po’ troppo all’Italia nel bene e nel male; la Scozia sembra già paga di essere l’unica rappresentante del calcio britannico, ed è preoccupatissima per l’assemblaggio di una squadra con giocatori quasi tutti del campionato inglese.
Restano, come valori assoluti, sia pure per ragioni diverse, il Brasile, ancora abbondante di talenti e intanto sempre più valido quanto a praticità, e l’Argentina, per via del fattore campo. Riesce, in sostanza, difficile immaginare un campionato che in qualche modo, almeno per due dei quattro posti delle finalissime per il titolo e per la terza piazza, non si consegni al Brasile e all’Argentina. Il pronostico, anzi, da un certo punto di vista, sembra più facile che mai: Brasile e Argentina da una parte, Germania e (ancora, nonostante tutto) Olanda dall’altra.
Davvero il pronostico passa, indifferentemente, dall’elementarità più assoluta alla complessità più divertente. Lo lasciamo interamente al lettore, o per meglio dire al telespettatore, visto che questo è ormai il bipede che si impone, nella tipologia dell’appassionato calcistico. Piuttosto, vogliamo segnalare un altro tipo di pronostico, o se preferite di non pronostico relativo alla undicesima edizione della Coppa del Mondo.
Vogliamo cioè dire che non si vede, non si intravede nel cielo della Coppa FIFA una possibile stella. Nel 1958 il nome grosso era stato quello di Pelé. Comunque, intorno a lui, altri avevano potuto brillare, e c’era stato posto per astri assortiti, nel cielo della notorietà. Questa volta, il cielo è nero, e chissà se ciò vuol dire che è sgombro oppure che è infrequentabile.
Esiste addirittura la possibilità che, sul piano di un’affermazione grande, ancorché non cosmica come quella di Pelé, la Coppa del Mondo 1978 laurei, alla fine, due oriundi italiani: il brasiliano Roberto Rivelino, più che trentenne, e il francese Michel Platini, poco più che ventenne. Dovrebbero essere loro i due massimi talenti, ancorché Pelé si proponga, come elemento di paragone, su ben altre orbite. Per il resto, nessuno appare in grado di raccogliere non diciamo, no, la successione del grandissimo Pelé, ma neppure quella dei grandi Cruyff e Beckenbauer, gli eroi (se ci passate la parola) della Coppa del Mondo 1974. Curiosamente, proprio il football mondiale, che sembra voler tornare a certi valori artistici primari, al culto del toque sudamericano, insomma alla identificazione gloriosa dell’estro, alla santificazione della classe pura, non ha gli atleti in grado di interpretare questa novità. C’è una mediocrità, non si sa quanto aurea, che meglio funzionerebbe se messa al servizio di un -football eminentemente atletico.- Ma lo stesso football atletico sembra ormai aver definito i suoi limiti. In pochi anni, è stato abbastanza facile per tutte le scuole eruttare giocatori capaci di correre velocemente, di saltare bene in alto, di essere feroci nel contrasto con l’uomo. Si dice adesso che bisogna, molto semplicemente, molto tragicamente, insegnare a questi splendidi animali atletici anche il gioco del football.
Le prime righe di questa trattazione sono state dedicate al fenomeno telecalcistico, più che al fenomeno calcistico tout-court, rappresentato dalla Coppa del Mondo. Vogliamo, dobbiamo chiudere nella stessa tematica. In altre parole, riteniamo giornalisticamente doveroso fornire al lettore la chiave, o le chiavi, per godersi televisivamente la Coppa del Mondo.
Esiste ormai per il giornalista, per lo scrittore di cose sportive, una realtà isolata e povera che potremmo definire «dell’occhio nudo». Il tempo del giornalista grande e unico testimone oculare, cantore di cose che solo lui ha visto o comunque che solo lui è in grado di dire di avere visto, sembra definitivamente tramontato. Ridicolissimo addirittura appare l’atteggiamento pontificante dei giornalisti calcistici i quali pretendono di spezzare il pane di una loro verità, su giornali che vanno in mano al lettore dodici ore dopo la sequela, la sequenza delle testimonianze televisive, e che hanno fornito al lettore documentazioni assolutamente superiori a quelle in mano al giornalista «testimone oculare». Dire, scrivere di un gol che «forse era in fuorigioco» per lettori che, quando entrano in possesso del giornale e diligentemente, benevolmente leggono l’articolo, conoscono già tutta la verità elettronica a proposito di quel gol, è per lo meno ridicolo.
Purtroppo la stampa sportiva di tutto il mondo non ha ancora accettato pienamente questa nuova realtà. I giornalisti ritengono disdicevole soffermarsi a commentare le immagini televisive, quelle dei nuovi occhi elettronici, quelle che in fondo sono le sole che contano; e anziché corredarle, casomai, della loro realtà di testimoni oculari, intendono contrapporre a esse questa realtà eminentemente personale. Lo stridore fra quanto i giornalisti scrivono, quanto i tifosi vedono, quanto i lettori si attendono di veder trattato sui giornali, è totale.
Noi qui proclamiamo solennemente un atto di resa del giornalismo scritto di fronte al giornalismo elettronico, della stampa scritta di fronte alla televisione. Noi pensiamo che sia ormai giunto il tempo di offrire una chiave di «lettura» degli incontri secondo le testimonianze che la televisione porta. Ovviamente non possiamo fornire direttive di comportamento, come invece si può fornire un lessico per la comprensione di certi articoli. Le riprese televisive dipendono dalla postazione delle telecamere, dalla volontà o dall’estro del regista, e soprattutto acquisiscono una loro validità a seconda della quantità e qualità degli eventi che il campo offre. Non si tratta, in sostanza, di una commedia classica da interpretare secondo copione, bensì di una commedia dell’arte.
Pensiamo tuttavia d’essere in grado di dare alcuni consigli al telespettatore perché si goda meglio, perché capisca bene la Coppa del Mondo 1978.
Per il telespettatore italiano questi sono i primi campionati del mondo con trasmissione a colori. Il primo consiglio, assolutamente particolare, è quello appunto di non lasciarsi ingannare dai colori. Già i registi sono da essi attratti, c se un portiere ha una maglia color zafferano, certamente godrà di più insistite inquadrature. I colori, per naturali che siano, possono, proprio perché cattivanti nei riguardi della regia, influenzare il telespettatore. Di regola, un giocatore biondo è meglio seguito, meglio notato e generalmente meglio apprezzato di un giocatore castano o bruno. Una squadra coi colori vistosi richiama l’attenzione del regista prima e del telespettatore poi, e di fronte al rischio minimo di vedere evidenziate le sue gaffes conosce, positivamente, una migliore «propaganda» sul video.
La regia argentina nel campionato del mondo è una regia in un certo senso esordiente alle grandi manifestazioni calcistiche. È pensabile che i registi argentini (fra l’altro in quella nazione le trasmissioni a colori sono state inaugurate proprio il 14 gennaio 1978 con la trasmissione sul sorteggio dei gironi mondiali) indulgano a effetti che a loro paiono sconvolgenti, mentre per i registi europei risultano già da tempo «consumati». Ricordiamo che esistono, comunque, due tipi assai diversi di regia: quella a tutto campo, con il più possibile di terreno inquadrato nel video, e quella del cosiddetto primo piano, messo in auge soprattutto dalle esercitazioni, sovente validissime, dei registi inglesi. Il telespettatore non deve farsi distrarre né dal tutto campo, né dal primo piano. Nel primo caso rischia di smarrire il particolare, a esempio la palla, il piede, il volto, a vantaggio di una visione del gioco che comunque non può essere generale, dal momento che, sempre, qualcuno o qualcosa sta fuori dal monitor. Nel secondo caso rischia di indulgere, immediatamente con simpatia o perlomeno con eccessiva attenzione, al particolare, allo spettacolo a tutti i costi. Anche un brocco, ripreso in primo piano, sprigiona pathos e quindi attrazione. Un particolare delle rughe di una vecchia zia è sempre molto interessante.
In ogni caso, sul piano della cultura televisiva, del mestiere di telespettatore, c’è ancora molto cammino da fare. Purtroppo, per larga parte del mondo, l’evento offerto dalla televisione è ancora l’epifania magica, nei riguardi della quale non si va tanto per il sottile: già il fatto che arrivi l’immagine, e che sia nitida, è sufficiente a creare spettacolo. Manca assolutamente un’ideologia giornalistica della ripresa televisiva, e di contro non si può dire che ci si attenga alla pura documentazione. Dando, in cabina di regia, le immagini di una partita di football, si può autenticamente alterare, nelle menti del telespettatore lontano, l’essenza stessa della partita. A chi guarda, questa volta, insieme con l’augurio di buon divertimento, c’è la raccomandazione della vigilanza. L’evento televisivo sta sovrapponendosi all’evento vero e proprio; attraverso di esso è possibile la più colossale manipolazione non solo dei cervelli, non solo dei sentimenti, ma anche delle cornee.
Regolarmente si chiede a chi scrive, per il solo fatto, eminentemente carismatico, di avere a disposizione un foglio bianco su cui porre e imporre dei segni neri, un pronostico su quanto sta per accadere: questo, ovviamente, se si tratta di un articolo, o di un libro relativo alla presentazione di un determinato evento.
L’undicesimo campionato calcistico mondiale pare avere (e così giochiamo anche noi al gioco dei pronostici) una fisionomia abbastanza precisata. Si parla di quattro squadre che dovrebbero, comunque, fare il bello e il brutto tempo, nel mite inverno argentino. Le quattro squadre sono (già detto) Germania Occidentale, campione del mondo uscente, Brasile, titolato come nessun altro, Argentina, padrona di casa, e Olanda, ancora sullo slancio del mondiale di quattro anni fa. Qualche riserva per l’ultimo nome: l’Olanda, con i suoi giocatori troppo sparpagliati per il mondo, troppo mercenari come mentalità, non è più lo squadrone di una volta. Possibile che una Polonia, un’Italia, una Francia, una Scozia, una Svezia, una Spagna possano sostituirla. Comunque sulle altre tre squadre non pare possibile una discussione.
Per possanza atletica i tedeschi, per talento gli immarcescibili brasiliani, per spinta del pubblico (e anche degli arbitri) gli argentini, sembra proprio che tre nomi su quattro, per le due semifinali, siano già scritti sul cielo alto della Coppa FIFA. Abbiamo già detto che si attende la pratica, perlomeno parziale, di un football artistico, che da un certo punto di vista potrebbe mettere in difficoltà i tedeschi. Non si pensa, tuttavia, che il verbo atletico possa essere completamente cancellato dal verbo tecnico. Casomai si crede a un verbo tecnico che suffraga il verbo atletico, risultandone a sua volta suffragato. Insomma, fare i bei giochi, i bei giochetti di una volta, però saltando più in alto, correndo più velocemente.
In questo football nuovo, formato dalla fusione di due football antichi, cosa può fare, cosa può dire l’Italia? Sulle possibilità della squadra azzurra sono tutti, in Italia, insieme eccezionalmente speranzosi, eccezionalmente preoccupati, eccezionalmente competenti. La Nazionale, che dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo di quattro anni fa è stata affidata prima a Bernardini, poi a Bernardini con Bearzot, poi al solo Bearzot, si è qualificata con difficoltà, e tuttavia con merito. Ha tolto dal Mondiale l’Inghilterra che, se si fosse presentata alla fase finale al posto dell’Italia, immediatamente, automaticamente sarebbe diventata una compagine favorita.
Si vuole che l’Italia stia attraversando un momento delicato (per l’Italia calcistica, diciamo: per l’altra, il momento è sempre delicatissimo), con la rinuncia al catenaccio, a un difensivismo che pure nel passato ci diede i suoi buoni premi, e con l’adesione a un football offensivistico. È perfettamente vero, è vero pure che ci sono i talenti (Graziani e Bettega soprattutto) per questa operazione d’attacco. Ma è vero anche che non c’è, dietro questo rinnovamento, quella che si chiama un’autentica spinta popolare. C’è invece molta paura di voler essere, a ogni costo, a ogni prezzo, in sintonia con i cosiddetti tempi nuovi. C’è persino chi dice che, praticando il nostro solito antiquariato calcistico, per tarlato che esso sia, si finirebbe per avere maggiore pregio e migliori esiti. Si scomodano altresì le differenze razziali, per le quali l’italiano non potrebbe correre troppo, saltare troppo in alto, avventarsi troppo al pallone.
In realtà a noi pare che il massimo freno sia la nostra situazione psicologica. Non che basti dire ai giocatori italiani che essi sono fulmini di guerra, per trasformarli in fulmini di guerra. Ma certe prediche alla camomilla, certi inviti alla prudenza, sembrano davvero fatti apposta per togliere quel piacere dopante, eccitante, che consiste nel sentirsi, nel calcio come in altre faccende, cittadini di un mondo nuovo.
Qualsiasi pronostico sull’Italia comunque è, oltre che impossibile, irrispettoso della competenza di cinquantasei milioni di italiani in materia di football. Ci limitiamo a dire che nulla ci è precluso, purché si sia perfettamente certi di poter arrivare. Ma per acquisire questa certezza, questo «possesso» del futuro che fa parte e patrimonio di altre genti, bisognerebbe davvero spogliarci di troppa parte di noi stessi. Preferiamo pensare che la palla è rotonda, preferiamo lasciare al calcio una bella porzione di lotteria, sperando di tirar su il numero giusto. Contrariamente al passato, di questa lotteria abbiamo, perlomeno, comprato qualche biglietto.
Per finire, e per allacciarci alle righe di questo nostro dialogo col lettore non inghiottito subito dalla statistica, dalle cifre, dai nomi del Mondiale, dobbiamo ancora dire delle possibili implicazioni politiche della Coppa del Mondo.
Anzitutto, c’è il problema dell’Argentina, nazione a regime militare, nazione in cui una giunta di generali, al potere dal marzo 1976, ha imposto una feroce repressione contro ogni movimento di sinistra, arrivando a legittimare una larga parte di questa repressione proprio con le necessità di ordine pubblico in vista della Coppa del Mondo. Si pensa che il calcio, già strumentalizzato nella lunga vigilia, sarà ulteriormente usato nei giorni delle partite: per non dire poi di come potrà diventare bacchetta magica per la giunta militare argentina in caso di vittoria o comunque di affermazione parziale della squadra calcistica di quel paese.
Il problema non è, purtroppo, nuovo, e ne abbiamo già parlato. Si deve dire soltanto, riprendendo un discorso già tenuto molte pagine fa, che il caso dell’Argentina c il più evidente, diciamo pure il più lacerante, fra tutti i casi spiccioli (si fa per dire) che la Coppa del Mondo propone. Regimi come quello brasiliano, quello iraniano, quello tunisino, quello anche peruviano, affidano senz’altro al calcio un vasto compito di «polizia» speciale, all’inferno del loro paese. Non vorremmo tuttavia che si cadesse in sopravvalutazioni. Quando si scriveva che la clamorosa affermazione della Tunisia nel girone africano era il pane e il companatico per quel paese, a Tunisi esplodevano i più violenti scontri e le più violente sommosse operaie nella storia di tutta l’Africa, e doveva intervenire l’esercito, facendo molti morti. Evidentemente, il football non era stato, nei riguardi delle masse povere tunisine, quell’oppio che tutti credevano.
Già che ci siamo, segnaliamo anche, in chiave di previsione, un aspetto particolare del prossimo campionato del mondo. Manca (ecco il punto, per chi crede a certi punti) il calciatore superstar, manca anche l’ipotesi di esso. Gira e rigira da un nome all’altro, preso atto della rinuncia di Cruijff e della «fine» anche morale di Beckenbauer, passato ai dollari dei Cosmos newyorkesi, si può anche pensare che la Coppa del Mondo 1978 vedrà esaltati su tutti due oriundi italiani, il giovane «francese di Novara» Michel Platini e il vecchio «brasiliano di Avellino» Roberto Rivelino. Ci sono dieci anni tra i due, il ruolo (centrocampista) è identico, il modo di interpretarlo anche. Entrambi hanno un tiro folgorante (Rivelino però è soltanto mancino), entrambi sono «padrini» nelle loro squadre (Rivelino ha anche il baffo mafioso). Platini verrà presto a giocare in Italia, Rivelino forse chiuderà con il campionato mondiale.
Altre stelle grandi non si vedono. Baluginano, è il caso di dirlo, luci piccole e spicciole. C’e Temime, ala della Tunisia, tesserato per la squadra di Gedda, Arabia Saudita, prima vittima (felicissima di esserlo) dei petrodollari. C’è Fischer, tedescone robustissimo, frequentatore a oltranza del dialetto bavarese, centravanti ariete. C’è Kampes, argentino emigrato in Spagna, nel Valencia, grande cane da tartufi del gol. C’è Zico, altro brasiliano, bianco e immacolato nel gioco assai classico. C’è Cano, argentino di Spagna, acrobata dei tesseramenti per due paesi, due Nazionali. C’è Pirri, libero spagnolo di classe pura. C’è Trésor, negro antillano della Nazionale francese, libero di sicuro nerbo atletico. C’è Dalglish, scozzese che gioca in Inghilterra, un attaccante rissoso, per come interpreta i «dialoghi» col pallone e con gli avversari. C’è forse Sotil, vecchio zingaro peruviano, e c’è il suo connazionale Cubillas, entrambi attaccanti. E chissà se ci sarà qualche italiano: dicono all’estero Tardetti, più che Antognoni Bettega Graziani.
Però manca il nipote di Pelé, il figlio di Cruyff e di Beckenbauer. Almeno sulla carta. C’è posto insomma per la stella improvvisa, per la cometa che sbava luce e trascina i giornalisti «re magi». Ma è anche possibile che il nuovo football vieti l’espressione isolata del grosso talento, comandi invece lo stakanovismo atletico, la classe umiliata dal collettivo, il talento offerto alla cassa comune. L’interrogativo sulla possibilità del singolo di esprimersi nel nuovo football è in fondo l’interrogativo cosmico del prossimo Mondiale. Se non ha risposta, diventa da cosmico comico: e trionfa il football della manovalanza, aiuto!
In Italia si è parlato addirittura di speranze in una felice soluzione «calcistica» dei problemi politici, economici di prima estate. Un sistema molto offensivo di considerare non solo l’Italia tutta, ma anche il mondo del football. In realtà, senz’altro una visione politica accompagna la visione tecnica, agonistica, di ogni grande manifestazione sportiva. Ma, forse proprio perché se ne parla molto (e se ne parla anche qui), il gioco è ormai scoperto, ormai dichiarato. La gente sta al gioco soltanto se la soddisfa in pieno, e forse neppure in questa circostanza. È fortemente probabile che una vittoria del Brasile non cambi nulla nella mentalità, nella disperazione di un povero contadino del Nord-Est di quel paese, di un disperato di Recife. E questa è senz’altro una buona cosa: un calcio meno taumaturgico è, perlomeno, uno sport molto più onesto.
Ciò non toglie che, sul piano della cattura delle masse per molte ore di molti giorni, sul piano dell’impatto soprattutto te visivo con le popolazioni, una manifestazione come la Coppa del Mondo meriti ogni attenzione, e debba essere affrontata dai sociologi con molta cautela, molta cura, diciamo pure molto rispetto. Pensiamo che il 1978 debba segnare, dopo la conquista nel 1977, da parte del football, dell’india e della Cina, e con l’impatto televisivo che sicuramente si avrà nel mese di giugno, il definitivo abbandono, da parte di molti intellettuali, di posizioni snobistiche nei riguardi del grande evento sportivo. Le dimensioni sono tali, ormai, che cercando ancora di tenere lo sport nel suo ghetto, si finisce per ghettizzare quel poco di mondo che ancora sta fuori di esso.